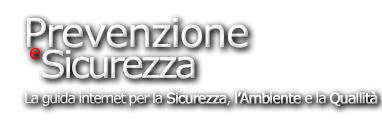News
"Datore di lavoro: l’esonero dalla responsabilità civile per infortuni"
fonte puntosicuro.it / Formazione ed informazione
02/04/2012 - I
Working Papers prodotti da
Olympus, Osservatorio
per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla
sicurezza del lavoro, sono una raccolta di brevi saggi dedicati al diritto
della salute e sicurezza sul lavoro che valorizzano l’attività di monitoraggio
svolta dall’Osservatorio e si soffermano spesso su elementi critici della
nostra normativa.
Presentiamo
oggi il Working Paper
3/2011
dal titolo “
La crisi della regola dell’esonero”, a cura di Stefano
Giubboni, professore associato di Diritto del lavoro nell’ Università di Perugia, un
saggio che analizza le
ragioni della
progressiva crisi della classica
regola
dell’esonero datoriale dalla responsabilità civile per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali.
Stiamo
parlando della regola sancita nell’
art.
10 del Testo
Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali del 1965, il DPR 1124/1965 che
recita “
l’assicurazione a norma del
presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per
gli infortuni sul lavoro. Nonostante l’assicurazione predetta permane la
responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale
per il fatto dal quale l’infortunio è derivato”.
Quella
dell’esonero è ancora oggi all’
apparenza
(stando, cioè, almeno alla lettera dell’art. 10)
la
“regola fondamentale che presiede al riparto di competenze tra il sistema
dell’assicurazione sociale obbligatoria e quello della responsabilità
civile in ordine alla riparazione del danno conseguente a infortunio sul
lavoro o a malattia professionale”.
L’autore
ci ricorda che il principio sottostante a tale regola è ugualmente (e sempre
all’apparenza) ancora molto chiaro e netto: ove operi il meccanismo di
socializzazione del rischio professionale basato sugli strumenti indennitari dell’assicurazione obbligatoria
facente capo all’INAIL, la responsabilità civile non ha ragione d’intervenire,
se non – in via eccezionale – per ‘sanzionare’ (assieme agli speciali strumenti
di rivalsa messi a disposizione dell’Istituto assicuratore” dall’art. 11 del Testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie
professionali) “una condotta (omissiva o commissiva) penalmente rilevante
del datore di lavoro”.
Tuttavia
a dispetto della “sua apparente continuità formale e lessicale”,
la regola “forse più longeva del nostro
diritto previdenziale” è “in crisi” da molto tempo e ha subito un lento declino.
L’autore
distingue
due tipologie di crisi, “a
loro volta riconducibili – scontando l’inevitabile dose di approssimazione
propria di ogni semplificazione analitica – a cause rispettivamente ‘endogene’
ed ‘esogene’ al sistema dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro:
-
una “
crisi di effettività”: con “riferimento a tutti quegli interventi,
non necessariamente modificativi del testo dell’art. 10”, ma “anche
semplicemente re-interpretativi del precetto in esso contenuto, i quali hanno
condotto ad una graduale restrizione delle condizioni di applicazione e del
raggio operativo della previsione medesima, la quale, per tal via, da regola
generale è di fatto divenuta norma che solo eccezionalmente inibisce la
riapertura del sottosistema dell’assicurazione contro gli infortuni al ‘diritto
primo’ della responsabilità civile”;
-
una “
crisi di legittimità”: con riferimento
“a quella giurisprudenza e a quelle ricostruzioni dottrinali che – trapiantando
in particolare nel sistema dell’assicurazione contro gli infortuni le
acquisizioni più innovative in tema di danno non patrimoniale alla persona e,
comunque, principi del tutto estranei alla originaria logica transattiva di
questo – finiscono per porre in discussione la legittimità in quanto tale della
regola dell’esonero, minandone alla radice le residue capacità operative e, in
prospettiva, le ragioni stesse della sua sopravvivenza nell’ordinamento, fosse
anche come caso di ‘
archeologia
giuridica’”.
Nelle
varie analisi e riflessioni presenti nel saggio, che vi invitiamo a visionare, è
presente la costatazione che “l’affermazione – dovuta ad una costante
giurisprudenza di merito e di legittimità – della
sostanziale unitarietà della nozione di colpa, civile e penale,
valevole ai fini dell’imputazione della responsabilità risarcitoria per
l’infortunio in capo al datore di lavoro” costituisce
un “potente fattore di erosione della rilevanza pratica della regola
dell’esonero e, perciò, una delle cause storicamente più significative di crisi
della sua effettività”.
L’autore
ricorda anche che a partire dalla sentenza 24 febbraio 2006, n. 4184, “la
Suprema Corte ha infatti innovativamente affermato che, per liberarsi dalla
presunzione che nell’ambito del rapporto di lavoro deriva dal combinato
disposto degli artt. 1218 e 2087 c.c.,
il datore deve dimostrare, anche nell’area governata dalla regola dell’esonero
di cui all’art. 10 del testo unico, di avere adottato tutte le cautele e le
misure atte ad evitare il danno subito dal lavoratore”.
Una
ancor più completa “crisi di legittimità” della regola dell’esonero è data poi dalla
proposta interpretativa di Aldo De Matteis (questo saggio riporta
il testo di una relazione in occasione di un incontro di studio correlato alla
presentazione del volume di Aldo De Matteis, “Infortuni sul lavoro e malattie
professionali”).
La
proposta è di leggere il comma 2
dell’art. 10 del testo unico come se dicesse:
nonostante l’assicurazione predetta, permane la responsabilità civile
per danno non patrimoniale in caso di colpa penale ovvero di lesione di diritti
inviolabili della persona costituzionalmente protetti. L’accoglimento di
questa proposta comporterebbe il definitivo superamento della regola
dell’esonero.
In
questa ottica – continua l’autore – “non appare oramai più ammissibile che il
diritto inviolabile alla salute del lavoratore – in quanto presidiato dalla
garanzia generale dell’art. 32 Cost. ed altresì assistito dalla più intensa
protezione specificamente offerta dall’art. 38 della Carta costituzionale –
possa subire restrizioni sul piano della tutela risarcitoria, proprio nel
momento in cui viene leso da un infortunio o da una tecnopatia imputabili alla responsabilità
del datore di lavoro”.
L’autore
conclude dunque indicando che la “
caduta
dell’ultimo simulacro della regola dell’esonero avrebbe del resto anche il
pregio di semplificare in radice i problemi di quantificazione del danno
differenziale, superando la distinzione – per certi versi incerta e artificiosa
– tra questo ed il danno complementare, escluso dalla copertura assicurativo-sociale”.
È
tuttavia probabile che la giurisprudenza si mantenga “su quella
linea storica, di più pragmatico
svuotamento dei suoi effettivi contenuti operativi”, svuotamento sintetizzato
nella formula della “crisi di effettività” della regola stessa.
E
comunque già oggi, di fronte al declino della regola dell’esonero, l’esonero
del datore
di lavoro non costituisce più la regola ma l’eccezione.
La
crisi di effettività della regola dell’esonero “
si risolve, con ogni probabilità, in una sua – pur non dichiarata –
crisi di legittimità”.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1118 volte.
Pubblicità