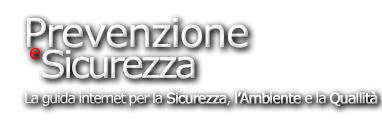News
"Le allergopatie professionali e gli allergeni di origine chimica"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
17/05/2016 -
Napoli, 17 Mag – L’introduzione nei settori produttivi di nuove
sostanze con potere sensibilizzante ha favorito l’esposizione dei
lavoratori alle
allergopatie professionali. E nei
luoghi di lavoro non ci sono solo gli allergeni di origine animale
(escrementi, piume, peli e residui cutanei, acari, ...), di origine
vegetale (graminacee, parietaria, cipresso, ulivo, betulla, fibre
naturali, cereali, farine, lattice, ...) e derivanti da funghi e
batteri, ma sono presenti anche molti
allergeni di origine chimica.
Per avere informazioni su alcuni di questi allergeni chimici, ci
soffermiamo ancora una volta su uno dei contributi presenti nella
pubblicazione “ Le malattie professionali. Aspetti clinici ed assicurativi”,
curata dalla Direzione regionale Campania dell’Inail. Una pubblicazione
che raccoglie gli atti di un corso quadrimestrale di formazione sulle
malattie professionali per operatori sanitari e consulenti delle parti
che si è tenuto nel 2012 a Napoli.
L’intervento “
Malattie allergologiche di origine
professionale: il rischio specifico”, a cura di Paola Pedata (Medico del
lavoro - Dottore di Ricerca SUN) – intervento che ci ha permesso nei giorni
scorsi di fare una panoramica delle “sindromi allergiche professionali” nei
luoghi di lavoro - ricorda che negli ambienti di lavoro gli allergeni
professionali di natura chimica che più spesso determinano l’insorgenza di patologie
allergiche respiratorie (asma in particolare) sono rappresentati da alcuni
composti:
-
isocianati, quali toluendiisocianato (TDI), metilendiisocianato
(MDI), esametilendiisocianato (HDI): “largamente usati nella fabbricazione di
spugne, schiume rigide o flessibili, rivestimenti quali pitture o vernici ed
elastomeri. I Di-isocianati sono sempre più usati nella industria
automobilistica e nella produzione di materiali per isolamento edilizio;
-
ossido di etilene: gas ampiamente utilizzato in ambiente
ospedaliero per la sterilizzazione di presidi medici e chirurgici quali
cateteri, tubi e in genere strumenti sanitari che non possono essere sterilizzati
in autoclave;
-
anidride ftalica, anidride maleica, anidride trimellitica: trovano
uso come intermedi nella sintesi di altri prodotti chimici”;
-
parafenilendiamina (PPD): “agente colorante usato nelle tinture per
capelli permanenti di tipo ossidativo. Sebbene la PPD sia prevalentemente
presente nei coloranti per capelli, sostanze che sono in grado di dare
reattività crociata possono essere presenti in molte tinture per tessuti, per
articoli in pelle, per pellicce e per gomme nere. La PPD, inoltre, è usata nei
tatuaggi all’henné nero per intensificare il colore, affrettare il processo di
colorazione e allungare i tempi di permanenza del tatuaggio;
-
formaldeide: usata principalmente per la produzione di resine
sintetiche (le cosiddette fenol-formaldeidiche) e di resine utilizzate nel
settore degli adesivi. Impiegata per la produzione di materie plastiche per
rivestimenti e nel finissaggio di tessuti oltre che come intermedio chimico per
sintesi di molecole più complesse. Trova uso, nell’industria anche come
‘sanitizzante’ e come ‘preservante’;
-
amine alifatiche: impiegate principalmente come intermedi nella
produzione di altri prodotti chimici tra cui polimeri (gomma, plastiche,
prodotti tessili), prodotti per l’agricoltura e farmaci”.
L’intervento si sofferma poi su
alcune sostanze chimiche che possono provocare dermatiti allergiche, ad
esempio sui
metalli:
-
cromo: riconosciuto allergizzante sia nella forma trivalente che
esavalente; la principale causa di allergia al metallo è il cemento;
-
nichel: è il più comune allergene; viene usato per la placcatura
dei metalli e componente di altre leghe;
-
cobalto: contenuto negli oggetti nichelati e nel cemento;
costituente di numerose leghe; utilizzato per produrre acciai speciali.
Composti del cobalto vengono utilizzati come coloranti (azzurranti) nelle
industrie della ceramica e del vetro, come catalizzatori nell'industria
petrolchimica e chimica e come catalizzatore nell'industria delle vernici;
-
mercurio: trova principale impiego nella preparazione di prodotti
chimici industriali e in campo elettrico ed elettronico. Ancora più vasti sono
gli utilizzi dei composti chimici del mercurio: catalizzatori, coloranti,
insetticidi. Molti degli usi comuni in passato, compresi erbicidi e farmaci,
sono stati abbandonati per la tossicità del mercurio”.
Si sofferma poi sugli
agenti chimici contenuti nella gomma:
-
tiurami: “si trovano in molti prodotti della gomma, inclusi scarpe,
guanti, grembiuli, giarrettiere, cinture elastiche dei vestiti, bende gommate,
manici di utensili, raccordi di tubi, rondelle, palloni di gomma. Si possono
trovare anche in adesivi per pelletteria, in prodotti vinilici”; sono contenuti
anche nei pesticidi, “prodotti anti-parassitari, anti-scabbia, fungicidi, oli
lubrificanti”, ...;
-
mercaptobenzotiazolo: “adoperato come acceleratore della vulcanizzazione
nell'industria della gomma, nei fluidi tecnici come anticongelante e oli da
taglio, nei detergenti speciali e nelle emulsioni fotografiche, nei
lubrificanti e come reattivo per la determinazione di diversi metalli pesanti.
Lo si può riscontrare anche in alcuni fungicidi e preparazioni medicali ad uso
veterinario;
-
parafenilendiamina:
trova impiego come intermedio primario nella produzione di azocoloranti,
coloranti per pellicce e pelli, negli sviluppi fotografici, negli antiossidanti
ed acceleratori usati nell’industria della gomma e della plastica, durante i
processi di fotocopiatura e litografia”.
Infine l’intervento riporta
diverse altre sostanze che possono essere responsabili di dermatiti allergiche:
-
resine epossidiche: “responsabili della sensibilizzazione sono
tanto la resina non polimerizzata che i numerosi additivi (indurenti, solventi,
plastificanti, coloranti, ecc.). Utilizzate nell’industria plastica, elettrica,
come legante nelle colle, come componente di
pitture e lucidi per barche, nelle vernici per unghie, coloranti per pelli
e moquettes, nella produzione di fibre di vetro rinforzate con parti in
plastica, come materiale di processo nei tessili e nella carta (carta da
computer), nei materiali da costruzione;
-
resine formaldeidiche: impiegate come collanti per legno, gomma,
metalli; anche utilizzate come isolanti elettrici;
-
resine acriliche: utilizzate nel trattamento delle fibre tessili,
come costituente di protesi ortopediche, odontoiatriche, pace-makers, del
plexiglas, etc;
-
coloranti derivati della anilina, derivati antrachinonici (eosina),
coloranti pirazolonici: sono largamente presenti in tessili, resine, gomme,
oli, petrolio, capi di vestiario, alimenti;
-
colofonia - resina naturale: presente in alcuni alberi (pino e
abete). Utilizzata in ambiente industriale come antiruggine per superfici
metalliche, come detergente per superfici difficili quale cuoio e macchine
utensili, in rivestimenti isolanti per apparecchi televisivi, come legante
naturale all’interno di varie vernici”;
-
oli: rappresentano “un gruppo di sostanze che nel tempo hanno
subito profondi cambiamenti”. Possono essere “classificati in tre gruppi
principali: oli solubili costituiti da emulsioni in acqua; oli insolubili a
base di idrocarburi paraffinici e oli sintetici”.
Il documento, che vi invitiamo a
visionare integralmente, riporta due
tabelle
con i principali agenti di rischio delle allergopatie professionali
respiratorie e cutanee ed i settori lavorativi interessati.
Concludiamo questa presentazione
delle malattie allergologiche
professionali riprendendo alcune
caratteristiche
peculiari delle allergopatie:
- “i soggetti affetti da
patologie allergiche generalmente manifestano la sintomatologia in seguito ad
esposizioni a basse dosi dell’agente, innocue per la maggior parte dei
soggetti;
- è necessario un periodo di
latenza tra l’inizio dell’esposizione e la comparsa della sintomatologia
(periodo detto di ‘sensibilizzazione’);
- la risposta all’agente
sensibilizzante è altamente specifica e la sensibilità all’agente tende ad
aumentare con il perdurare dell’esposizione;
- lo sviluppo della malattia
allergica sembra associato a predisposizione genetica”.
Segnaliamo, infine, che
l’intervento si sofferma anche sulla suscettibilità individuale dei lavoratori
e sui vari
fattori di rischio, ricordando
che il fattore di rischio maggiore è sicuramente “rappresentato dal livello
espositivo all’agente responsabile: più è elevato maggiore è il rischio di
sensibilizzarsi e dunque di manifestare una allergia alla sostanza”. Ma che rivestono,
inoltre, importanza “la durata e la frequenza dell’ esposizione
all’allergene”. E la frequenza di “picchi intermittenti di esposizione
(anomalie del ciclo produttivo, incidenti) sembra rivestire maggiore importanza
rispetto ai livelli medi di esposizione”.
Senza dimenticare che alcuni
fattori come l’inquinamento, le infezioni e il fumo “possono sommarsi e
svolgere un ruolo scatenante nei confronti dello sviluppo delle allergopatie”.
Inail - Direzione regionale
Campania, “ Le malattie professionali. Aspetti clinici ed assicurativi”,
atti del I Corso Quadrimestrale Di Formazione sulle malattie professionali per
operatori sanitari e consulenti delle parti che si è tenuto a Napoli tra marzo
e giugno 2012 (formato PDF, 4.07 MB).
RTM
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1506 volte.
Pubblicità