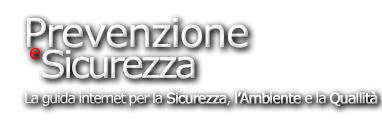News
"Prevenzione incendi: metodologia prescrittiva o prestazionale?"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio
14/05/2015 - Il futuro Testo Unico Prevenzione Incendi,
un documento che ha la funzione di snellire il corpus normativo
attraverso un processo di rinnovamento e semplificazione in materia, è
in continua evoluzione. Si succedono le versioni del testo e anche la bozza da noi pubblicata -
presentata ufficialmente nell’aprile 2014 con una conferenza stampa –
ha avuto nei mesi successivi alla presentazione diverse modifiche.
Di questa prima versione rimangono tuttavia sicuramente validi i
principi ispiratori, indicati chiaramente già nella bozza dell’anno
passato, e il tentativo di superare il diffuso
approccio prescrittivo della normativa, incrementando invece l’
approccio prestazionale.
Ma cosa significano realmente questi due approcci/metodologie, spesso citati nei commenti al futuro Testo Unico? In cosa consiste la differenza?
Per
rispondere possiamo fare riferimento ad un documento Inail dal titolo “ SICUREZZA
ANTINCENDIO. Valutazione del rischio incendio” che, in attesa dei decreti
attuativi indicati dal D.Lgs. 81/2008, si occupa degli
aspetti più progettuali dell’ingegneria antincendio: valutazione
del rischio d’incendio, modulistica di prevenzione incendi, approccio
ingegneristico alla sicurezza antincendio.
Il documento ricorda, infatti,
che la prevenzione incendi può essere approcciata secondo due
metodologie sostanzialmente differenti.
Il primo è l’
approccio ordinario, di tipo
prescrittivo,
un approccio “largamente diffuso in Italia, che si concretizza
nell'applicazione di regole
tecniche in cui sono riportate le misure da adottare ai fine di ottenere la
sicurezza antincendio e nel ricorso a strumenti di calcolo molto semplici (ad
esempio, gli Eurocodici per il calcolo analitico della classe REI delle
strutture, le curve standard d'incendio, ecc.). Le norme e le regole tecniche
impongono, in definitiva, di realizzare il livello minimo di sicurezza fissato
attraverso misure specificatamente prescrittive”.
Quali sono i pregi e i difetti del metodo prescrittivo?
Il vantaggio più evidente risiede
“nella sua estrema semplicità, nella garanzia di una sufficiente omogeneità di
applicazione, nel riscontro di accettabili criteri di uniformità da parte dei
controllori”.
Invece il limite maggiore
consiste “nella rigidità delle prescrizioni normative e delle procedure di
calcolo”. In particolare l'approccio ordinario alla sicurezza antincendio
“suddivide le misure di sicurezza in due gruppi, legati ai due principali
obiettivi dell'attività di prevenzione:
- le misure destinate a limitare
le probabilità che un evento incidentale si manifesti;
- le misure destinate a limitare
i danni nei casi in cui un incendio accada”.
Per determinare le misure di
sicurezza più idonee si possono utilizzare i criteri di valutazione del rischio
d'incendio (codificati nel Decreto
del Ministro dell’interno del 10
marzo 1998) oppure, quando sono disponibili delle norme, “attuare le
misure previste nelle singole disposizioni (adottate con decreto del Ministero
dell'Interno) che sono redatte secondo uno schema che espone i requisiti dei
diversi componenti edilizi, impiantistici e gestionali necessari per assicurare
il livello di sicurezza richiesto dalla collettività”.
Veniamo invece all'
approccio ingegneristico, al
metodo prestazionale.
In materia di prevenzione incendi
è possibile seguire in alternativa un approccio di tipo ingegneristico (
Fire Safety Engineering, FSE) che “si
basa sulla predizione della dinamica evolutiva dell'incendio tramite
l'applicazione di idonei modelli di calcolo. Quest'approccio, di tipo
prestazionale, permette di studiare le conseguenze degli incendi negli edifici
e di valutare, prima di realizzare l'opera, l'effetto sulle persone e sulle
cose degli incendi presi a riferimento”.
Quali sono i pregi e i difetti del metodo prestazionale?
Il principale vantaggio di questa
metodologia è “rappresentato dall'estrema flessibilità, che permette la
simulazione d'incendi di complessità anche elevata, previa valutazione di
alcuni dati di input (geometria del dominio di calcolo, tipo e quantità dei
combustibile, condizioni di ventilazione, curva HRR: Heat Release Rate/tempo, ecc.),
da assegnare con dettaglio variabile e secondo la tipologia del modello”.
I limiti di tale approccio,
diffuso specialmente nei paesi anglosassoni, “risiedono nella problematica
validazione sperimentale dei modelli utilizzati, considerata la natura distruttiva
delle prove che andrebbero condotte, nell'approfondita preparazione richiesta
ai professionisti ed, ancor più, ai controllori (considerato il proliferare
negli anni di modelli anche molto diversi tra loro), nella necessità di dover
congegnare un sistema di gestione della sicurezza mirato al mantenimento delle
condizioni operative individuate nello scenario di progetto, ed infine, nel
caso di modelli di campo più complessi, negli oneri di calcolo, spesso non
indifferenti”.
Ad oggi in Italia il ricorso alla
Fire Safety Engineering è “di fatto circoscritto alle applicazioni per le quali
non esiste una specifica norma prescrittiva, su tutte la valutazione del
rischio in attività a rischio d'incidente rilevante e la
Fire Investigation” (una tipologia di analisi utilizzata a livello
forense del fenomeno d'incendio, “al fine di poter caratterizzare cosa sia
accaduto, con buona probabilità, nell'ambito di un determinato luogo in seguito
a incidente o evento delittuoso); talvolta tale approccio è impiegato anche per
la valutazione della sicurezza equivalente in occasione di richiesta di deroga
a norme prescrittive”.
Il documento ricorda poi che con
il
Decreto Ministeriale del 9 Maggio
2007, concernente le " Direttive per l'Attuazione
dell'Approccio Ingegneristico alla Sicurezza Antincendio”, il Ministro
dell’Interno ha definito gli aspetti procedurali e i criteri da adottare per
valutare il livello di rischio e progettare le conseguenti misure compensative,
utilizzando, in alternativa a quanto previsto dal decreto del Ministro
dell'interno 4 maggio 1998, l'approccio ingegneristico alla sicurezza
antincendio. Con particolare riferimento a “complessi produttivi e costruzioni
civili di particolare pregio architettonico, destinati normalmente alla
fruizione da parte del pubblico e aventi un layout complesso”.
Secondo l’articolo 2 del DM
del 9 maggio 2007 la procedura ingegneristica è finalizzata alle due
attività che nella prevenzione incendi richiedono aspetti di valutazione dei
rischio e delle misure da attuare:
- “all'individuazione dei
provvedimenti da adottare nell'ambito delle attività soggette alla disciplina
di prevenzione incendi, nel caso di attività non regolate da specifiche
disposizioni antincendio;
- all'individuazione delle misure
di sicurezza che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo
nell'ambito del procedimento di deroga”.
Dunque il provvedimento normativo
stabilisce un “nuovo iter procedurale che si affianca, ma non sostituisce,
quelli esistenti; in altre parole, i titolari delle attività avranno la facoltà
di seguire i disposti del decreto, ma le previsioni in esso contenute non li
obbligano a seguire l'approccio ingegneristico”.
Il documento dell’Inail conclude
l’
analisi dei due approcci alla
prevenzione incendi chiedendosi se oggi l'approccio di tipo ordinario debba
considerarsi superato.
La risposta è negativa. Infatti
“nella maggioranza dei casi, tale approccio rappresenta ancora la scelta
migliore. Tuttavia, in alcune situazioni specifiche, le metodologie orientate
alla garanzia della prestazione antincendio consentono un approfondimento
dell'analisi del rischio d'incendio, ed una previsione utile ad evidenziare il
grado di sicurezza antincendio dell'edificio, anche in relazione a possibili
alternative di protezione, costituendo un valido strumento di supporto al
progettista, che, nell'ambito del processo di progettazione, può verificare la
risposta antincendio di differenti ipotesi progettuali”. E tali situazioni
specifiche possono ad esempio ricondursi a “edifici esistenti pregevoli per
arte e storia, ospedali
e case di cura, edifici caratterizzati da una notevole altezza, da un
layout complesso o ancora, da soluzioni tecnologiche particolari, altri edifici
destinati all'impiego da parte di un elevato numero di persone (ad esempio
stadi, auditorium, ecc.), costruzioni complesse (ad esempio tunnel, ecc.)”.
Insomma il progettista deve avere una “visione globale del problema” e saper
valutare “se, e quando, possa essere necessario adottare misure alternative o
integrative di quelle previste dalle normative e dai codici prescrittivi”.
In definitiva le
norme prescrittive rappresentano “un
requisito necessario, ma non sempre
sufficiente, al fine della garanzia del raggiungimento di un adeguato livello
di sicurezza antincendio”. Con il DM 9 maggio 2007 sono fornite alcune
linee guida “che il professionista esperto può adottare al fine di migliorare
la propria strategia antincendio, risolvere le problematiche specifiche
sopradescritte, verificare l'equivalenza tra misure di protezione (attive e
passive), anche attraverso un migliore uso della simulazione quale strumento
approfondito d'indagine dell'incendio. Ciò significa anche che quando, ad
esempio, la normativa stessa non possa essere applicata tout court, a causa ad
esempio di vincoli architettonici, è necessario comunque delineare un sistema
di protezione con un livello di sicurezza equivalente (misurabile) a quello
prescritto (o superiore)”.
INAIL, Settore Ricerca
Dipartimento Tecnologie di Sicurezza “ SICUREZZA ANTINCENDIO. Valutazione del rischio incendio”, a
cura di Raffaele Sabatino INAIL, Dipartimento Tecnologie di Sicurezza con la
collaborazione di Andrea Cordisco (INAIL, Dipartimento Installazioni di
Produzione e Insediamenti Antropici) e Massimo Giuffrida INAIL, Dipartimento
Tecnologie di Sicurezza), edizione 2014 (formato PDF, 7.98 MB).
Vai all’area riservata agli
abbonati dedicata a “ Sicurezza
antincendio e valutazione dei rischi”.
RTM
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1097 volte.
Pubblicità