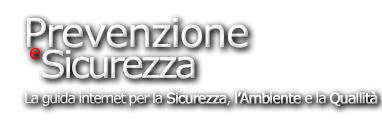News
"Datore di lavoro e obbligo di sicurezza"
fonte puntosicuro.it / Normativa
17/04/2012 - I
Working Papers - brevi
saggi
prodotti da
Olympus ( Osservatorio
per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla
sicurezza del lavoro) e dedicati al diritto della salute e sicurezza sul
lavoro - si sono già occupati del ruolo e delle responsabilità del datore di
lavoro. Ad esempio in relazione alla crisi
della regola dell’esonero datoriale dalla responsabilità civile per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Sulla
figura del datore di lavoro, osservato attraverso il microsistema della salute
e sicurezza sul lavoro, si sofferma anche il Working Paper
7/2012
dal titolo “
Datore di lavoro
e obbligo di sicurezza”, a cura di Chiara Lazzari, ricercatrice di
Diritto del lavoro nell’ Università di Urbino “Carlo Bo”.
Tale
saggio trae spunto da una più ampia ricerca che si sta conducendo sulla figura
del datore di lavoro, una ricerca che ad esempio vuole “verificare se, ed in
che termini, la
configurazione
dell’obbligo di sicurezza, e la connessa specificità della disciplina
dettata in materia, si rifletta sulle categorie fondanti del diritto del
lavoro, con specifico riferimento all’individuazione della figura datoriale ed
ai poteri dalla stessa esercitati”.
Un
saggio molto ricco di spunti e riflessioni, difficilmente sintetizzabili
all’interno di un articolo, che vi invitiamo a leggere interamente.
Con
questo nostro articolo possiamo tuttavia sottolineare alcuni aspetti, alcuni
elementi di discussione rilevati dall’autrice.
Ad
esempio la
scarsa attenzione del diritto
del lavoro nei confronti della pur importante figura del datore di lavoro, “a
partire dall’indifferenza manifestata dal codice civile, che, nell’art. 2094,
si limita a riferirsi al prestatore di lavoro ed all’imprenditore, quest’ultimo
individuato nei precedenti artt. 2082 e 2083”. O anche la difficoltà sempre
maggiore di
identificare il datore di
lavoro, “a causa della frammentazione indotta dai concomitanti processi di
decentramento produttivo”, con conseguente
disarticolazione
della (sua) figura economica e giuridica” [1].
Inoltre
il saggio offre una
disamina sulle
“definizioni” della figura datoriale sia in relazione al diritto
comunitario che alla normativa nazionale, con riferimento al Decreto legislativo 81/2008.
Ad
esempio ci si sofferma sulla
direttiva 89/391/CEE
- concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro – dove
ai fini della presente direttiva, per
datore di lavoro si intende
qualsiasi
persona fisica o giuridica che sia titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore e abbia la responsabilità dell’impresa e/o dello stabilimento.
Insomma
“quella cui ricorre la normativa comunitaria, e, di riflesso, il legislatore
nazionale, è una
tecnica di tipo
funzionale, che, in altri termini, utilizza “
canoni funzionalistici di individuazione del datore di lavoro,
che si connota diversamente a seconda del
contesto e dei fini che l’ordinamento intende realizzare” [2].
Tale tecnica “è tesa a definire, per l’appunto funzionalmente rispetto ai
diversi fini di volta in volta perseguiti dall’ordinamento (nel caso specifico,
garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori), chi assume
la qualità di datore di lavoro nell’ambito
della normativa considerata”.
Veniamo
al
D.Lgs. 81/2008 che all’art. 2,
comma 1, lett. b, definisce il datore di lavoro (privato) quale
soggetto titolare del rapporto di lavoro con
il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha
la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto
esercita i poteri decisionali e di spesa.
Dunque
una “nozione ampia della figura datoriale, da intendersi sia in un’accezione
formale che sostanziale”, che sembra portare a compimento un definitivo
divorzio tra la collaudata strumentazione civilistica e la materia
prevenzionistica.
Tale
definizione sembra affiancare “a parametri di tipo giuridico (la titolarità del
rapporto di lavoro) una
responsabilità
fondata su nessi organizzativi, in grado di scongiurare “forme improprie
d’imputazione di responsabilità in capo a chi datore di lavoro sia solo perché
formalmente parte contrattuale, anche in assenza dell’attribuzione delle
necessarie prerogative” [3]
e capace altresì di “tutelare maggiormente il lavoratore”.
La
nozione di datore di lavoro potrebbe essere “non necessariamente collegata alla
titolarità formale del contratto ma al rapporto organizzativo che si instaura
tra una persona fisica o giuridica e coloro che svolgono attività lavorativa” [4]
a favore dell’organizzazione, “potendo, poi, l’integrazione in quest’ultima
individuarsi sulla base di elementi diversi (come l’ambito spaziale in cui si
svolge la prestazione od il suo collegamento funzionale con le finalità
datoriali, per stare alle previsioni del d.lgs. n. 81/2008 in tema di lavoro
parasubordinato e telelavoro)”.
Ne
deriva dunque la necessità di “un’accurata indagine sulle caratteristiche della
specifica
realtà organizzativa, così da identificare il soggetto
detentore del potere di determinarla o modificarla”. Inoltre si sottolinea che nell’attuale
formulazione della norma “il profilo sostanziale risulti per altro verso
ulteriormente accentuato rispetto alla legislazione previgente, stante il
riferimento non più alla ‘
titolarità’
dei poteri decisionali e di spesa, ma all’ ‘
esercizio’ dei medesimi, quale criterio in grado di connotare in termini di
‘responsabilità’ la relazione tra figura datoriale ed organizzazione”.
Il
saggio approfondisce poi il tema della diffusione del “
debito di sicurezza” e della “
multidatorialità”.
Infatti
attribuendo la qualifica di datore
di lavoro “altresì a chi, nel settore privato, abbia la responsabilità –
connessa all’esercizio di poteri decisionali e di spesa – anche della singola
unità produttiva, il legislatore ammette una potenziale
‘diffusione del debito di sicurezza’ fra una pluralità di datori di
lavoro ‘sostanziali’”.
E
il canone di effettività permette/impone una “moltiplicazione dei datori di
lavoro in senso sostanziale sconosciuta alla tradizione civilistica, che può
indurre a ragionare in termini di “multidatorialità” (più che di
codatorialità)”.
Dirimente
appare poi il fatto “che il singolo datore non può liberarsi della posizione di
garanzia a lui ascritta, stante il carattere penalmente sanzionato della
materia, se non tramite lo strumento
della delega”. Questa, però, oltre ad incontrare i limiti posti dallo
stesso D.Lgs. 81/2008, si configura quale “atto di traslazione di poteri, e
connesse responsabilità, fra aree funzionali distinte (segnatamente, dal datore
di lavoro rispetto a soggetti altri), non fra datori di lavoro”. E c’è da
chiedersi “se la posizione dei datori possa allora essere assimilabile a quella
dei soggetti passivi di un’obbligazione collettiva, alla cui esecuzione debbono
necessariamente partecipare più debitori in virtù della natura della
prestazione stessa”.
Il
saggio continua proprio sul tema della “
imputazione
plurisoggettiva del debito di sicurezza” e sulla possibilità che per
dirigenti, preposti e delegati possa ipotizzarsi
una situazione di codatorialità.
Ad
esempio, con riferimento alla figura del delegato, “si può osservare che,
sebbene anche nel caso del datore di lavoro si appalesi la necessità di
disporre di poteri finanziari e decisionali congrui, al pari di quanto oggi
richiesto in materia di delega dall’art. 16 d.lgs. n. 81/2008, sussiste
l’essenziale differenza connessa al titolo in base al quale la responsabilità risulta
ascritta: infatti – analogamente a ciò che avviene per dirigenti
e preposti – detta responsabilità è addebitata al datore di lavoro a titolo
originario, e non in via derivata, come, invece, per il delegato; cosicché il
medesimo non incontra le limitazioni previste dall’art. 17 in ordine al contenuto della
delega, nel senso che, in quanto datore, sarà tenuto ad adempiere altresì
gli obblighi cosiddetti indelegabili”.
E
quanto alle figure del dirigente e del preposto, “lo schema di ripartizione ‘a
cascata’ degli oneri prevenzionali”, confermato dal D.Lgs. 81/2008, “non sembra
determinarne un’equiparazione con il datore di lavoro, responsabile dell’intera
organizzazione o della singola unità produttiva”.
Rimandando
il lettore alle riflessioni del saggio sul rapporto tra organizzazione,
contratto di lavoro e contenuto dell’obbligo di sicurezza, concludiamo con
qualche cenno al rapporto tra
potere
organizzativo/direttivo e obbligo di sicurezza.
Infatti
“il quantum di debito di sicurezza gravante sui vari obbligati della linea
aziendale (datore di lavoro, dirigenti, preposti) risulta strettamente connesso
– in termini di proporzionalità – alla frazione di potere organizzativo e
direttivo esercitato dai medesimi, costituendo la sicurezza del lavoro un
limite all’esercizio di quel potere per chiunque ne disponga”.
E
anche il legislatore all’art. 30, comma 3, d.lgs. n. 81/2008 “richiede, in
termini prescrittivi e non facoltativi”, che il modello organizzativo debba
in ogni caso prevedere
un sistema disciplinare idoneo a sanzionare
il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
E
, “proprio relativamente all’interpretazione del citato art. 30, dalla Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro viene un’indicazione meritevole di
approfondimento [5]:
quella, cioè, per cui è l’
Alta Direzione
aziendale, “ossia il datore di lavoro in senso civilistico, a dover
definire e formalizzare il predetto sistema disciplinare, che dovrà poi essere
diffuso a tutti i soggetti interessati, tra cui in primis il datore di lavoro
prevenzionistico”.
In
altri termini – e con questa riflessione dell’autrice concludiamo questa
frammentaria presentazione del saggio – “chi assume la qualità di datore di
lavoro a fini prevenzionali la assume perché la frazione di potere
organizzativo/direttivo da lui esercitato gli consente di intervenire per
evitare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli; ed al potere direttivo
non può che accompagnarsi anche quello disciplinare, volto, nel caso specifico,
alla tutela dell’organizzazione di lavoro nelle sue esigenze di sicurezza”.
Olympus
- Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e
giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, “ Datore
di lavoro e obbligo di sicurezza”, a cura di Chiara Lazzari, ricercatrice
di Diritto del lavoro nell’Università di Urbino “Carlo Bo”, Working Paper di
Olympus 7/2012 (formato PDF, 328 kB).
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1865 volte.
Pubblicità