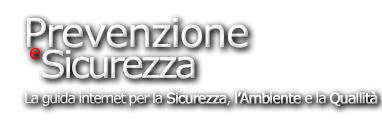News
"Valutazione del rischio: il Documento di Protezione Contro le Esplosioni"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio Esplosione - Atmosfere Esplosive
04/06/2015 -
Pubblichiamo un estratto della
relazione “La gestione del rischio di
esplosione sulle attrezzature a pressione: il Documento di Protezione Contro le
Esplosioni”
presentata in
occasione della VI edizione Safap che espone i criteri
adottati per l’individuazione del rischio di esplosione, la valutazione
dell’efficacia delle possibili sorgenti di innesco previste dalla normativa
EN-1127-1.

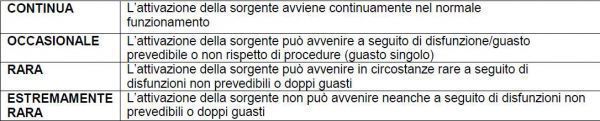
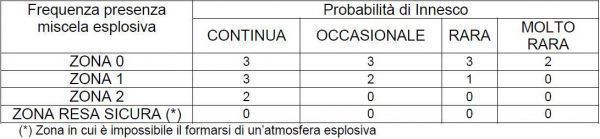
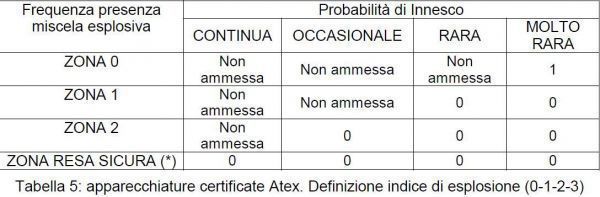
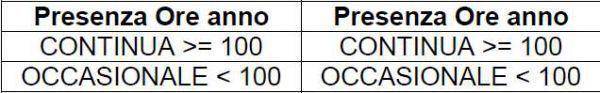

La gestione del rischio di esplosione sulle attrezzature a pressione:
il Documento di Protezione Contro le Esplosioni
A cura di G. Chiofalo, F. D’Antonio, A. Scaglione
Tra le novità introdotte del DL
81/08 (Testo Unico sulla sicurezza), vi è l’obbligo del Datore di Lavoro di
redigere e mantenere aggiornato il Documento sulla Protezione Contro le Esplosioni,
in cui si esplicita che sono stati individuati e valutati i rischi di
esplosione ed adottate adeguate misure per la corretta gestione di tali rischi
entro limiti accettabili. Nella presente memoria, la Raffineria di Milazzo
espone la propria esperienza e le metodologie adottate nella gestione del
rischio di esplosione associato agli impianti di processo, in particolare per
quanto riguarda le attrezzature a pressione, così come è stato sviluppato nei
Documenti sulla Protezione Contro le Esplosioni delle varie unità produttive dello
stabilimento. Vengono quindi esposti i criteri adottati per l’individuazione
del rischio
di esplosione, la valutazione dell’efficacia delle possibili sorgenti di
innesco previste dalla normativa EN-1127-1. Particolare spazio della memoria
viene dedicata alle misure intraprese per la gestione delle sorgenti di innesco
da superficie calda, individuate per attrezzature a pressione con temperature
di esercizio superiori alla temperatura di accensione delle sostanze esplosive
relative alla classificazione dell’area di installazione delle apparecchiature.
[…]
2. Il Documento sulla Protezione Contro le Esplosioni (DPCE)
Inizialmente indicato nella
Direttiva Europea 1999/92/CE, recepita nel nostro paese con Decreto Legislativo
12 giugno 2003, n. 233, questo concetto di valutazione del rischio di esplosione,
intesa come obbligo del datore di lavoro, è stata inserita nel DL 81/08 (Testo Unico
sulla sicurezza), in particolare al TITOLO XI: PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE,
CAPO II, art. 294, in cui sui recita:
“1. Nell'assolvere gli obblighi
stabiliti dall'articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere
aggiornato un documento, denominato: «Documento sulla Protezione Contro le
Esplosioni».”
In particolare in questo
documento deve essere precisato che:
- i rischi
di esplosione sono stati individuati e valutati, che verranno prese le
misure necessarie per ottemperare a quanto richiesto dal TU,
- quali sono i luoghi che sono
stati classificati a rischio di esplosione,
- quali sono i luoghi in cui si
applicano le prescrizioni minime di cui all’allegato L del TU,
- che i luoghi e le attrezzature
di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e
mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza.
L’analisi del rischio
d’esplosione comprende i seguenti elementi:
a) individuazione delle sostanze
infiammabili presenti e delle loro caratteristiche di esplosività;
b) determinazione della
probabilità che si formi un’atmosfera esplosiva pericolosa;
c) determinazione della presenza
e della probabilità di sorgenti d’accensione efficaci;
d) determinazione dei possibili
effetti di un’esplosione;
e) stima e valutazione del rischio.
Se il rischio non è accettabile,
occorre individuare delle misure di eliminazione o minimizzazione del rischio.
Le attività relative ai punti a)
e b) vengono svolte durante la fase di classificazione delle aree. Nel DPCE
vengono più specificatamente sviluppati i punti successivi, e vengono inoltre
stabilite eventuali misure necessarie alla riduzione o mitigazione del rischio determinato.
2.1 Definizione e stima del rischio di esplosione
In accordo alla definizione
ingegneristica rischio (probabilità per conseguenza), anche il rischio
d’esplosione deriva dalla combinazione della probabilità che si verifichi un
danno o una lesione ai lavoratori esposti a un’esplosione (che si può
verificare solo per concomitante presenza di atmosfera esplosiva e di sorgente
di accensione efficace, ma anche prescinde dalla presenza dei lavoratori in
tale luogo) e dalla gravità di tale danno. Sono disponibili in letteratura
numerosi metodi per l’analisi sistematica di questi elementi. In pochi casi
tali elementi possono essere determinati con esattezza, perlopiù possono essere
solo stimati. Dopo l’individuazione dei rischi, occorre che questi vengano quantificati,
e se è quindi necessaria una loro riduzione, o se si è di fronte ad una situazione
sicura. Se è necessaria la riduzione dei rischi, si devono scegliere ed
applicare appropriate misure di sicurezza, e si deve ripetere l’analisi per
assicurarsi che gli obiettivi di riduzione del rischio siano raggiungibili con
l’implementazione di tali provvedimenti. È importante che si verifichi anche se
nell’applicazione delle suddette misure di sicurezza si ad essi associati. Gli
obiettivi di riduzione del rischio si possono considerare raggiunti nel caso in
cui si può ragionevolmente escludere il verificarsi di un’esplosione che
arrechi un qualunque danno o lesione ai lavoratori interessati. Nello
specifico, durante l’elaborazione del DPCE negli impianti di processo della
Raffineria di Milazzo, gli elementi del rischio
d’esplosione sono stati stimati semi-quantitativamente, in accordo a quanto
indicato dalla norma CEI-31-35. Di seguito viene illustrato il metodo adottato.
Partendo dalla classificazione delle aree, si può associare un probabilità di
formazione di atmosfera esplosiva:

Tabella 2: probabilità di formazione atmosfera esplosiva
Quindi si valuta la presenza di
eventuali sorgenti di innesco, in accordo alla norma UNI EN 1127-1. Tale norma
prevede che vengano valutate le seguenti origini di sorgenti di innesco, per
ciascuna delle quali se ne dovrà stabilire oltre che la sussistenza, anche l’efficacia:
-
superfici calde;
-
fiamme e gas caldi (incluse le particelle
calde);
-
scintille di origine meccanica;
-
materiale elettrico;
-
correnti elettriche vaganti, protezione contro
la connessione catodica;
-
elettricità statica (scintille, scariche a
fiocco, scariche propagantesi a fiocco, scariche
-
a cono, ecc.);
-
fulmini;
-
onde elettromagnetiche a radiofrequenza (RF) da
104 Hz a 3x1012 Hz;
-
onde elettromagnetiche da 3x1011 Hz a 3x1015 Hz;
-
radiazioni ionizzanti;
-
ultrasuoni;
-
compressione adiabatica e onde d’urto;
-
reazioni esotermiche, inclusa l’autoaccensione
delle polveri.
Una volta che viene individuata
la presenza o meno di potenziali sorgenti di innesco, va valutato l’efficacia o
meno delle stesse. Per ciascuna sorgente di innesco considerata efficace, si
determina la probabilità di innesco, in base al seguente schema:
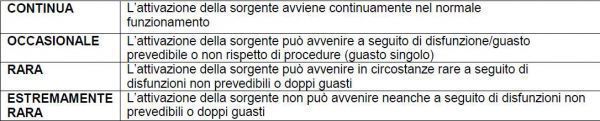
Tabella 3: definizione probabilità di innesco di una
sorgente efficace
Quindi si può calcolare l’indice
E di esplosione, dalla combinazione della frequenza di esplosione (quindi dal tipo di ZONA) e dalla
probabilità di innesco, in base alla seguente tabella, in cui, come si può vedere, tale indice viene
calcolato diversamente nel caso la fonte di innesco provenga da
un’apparecchiatura NON certificata Atex o certificata Atex.
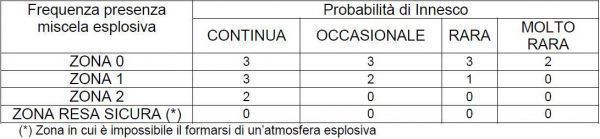
Tabella 4: apparecchiature NON certificate Atex.
Definizione indice di esplosione (0-1-2-3)
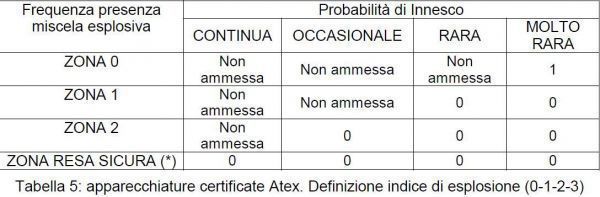
Tabella 5: apparecchiature certificate Atex. Definizione
indice di esplosione (0-1-2-3)
L’indice di esplosione
determinato, viene così classificato:
E=3 ALTO
E=2 MEDIO
E=1 BASSO
E=0 TRASCURABILE
Inoltre, la simultanea presenza
di più sorgenti di innesco derivanti da fonti distinte, dovrà essere
opportunamente valutata, eventualmente assegnando una probabilità di innesco continua.
Per quanto riguarda le conseguenze prodotte da una possibile esplosione, non si
considerano tento gli effetti derivanti da questo evento, in quanto sempre
catastrofici, bensì si pone più attenzione all’esposizione dei lavoratori, ed
alla presenza di misure di allertamento tali da fare allontanare i lavoratori
prima del verificarsi dell’esplosione. In funzione dell’organizzazione del
personale di reparto, si definiscono due livelli di esposizione, in base a
quanto riportato in tabella 6, ovvero CONTINUA e OCCASIONALE:
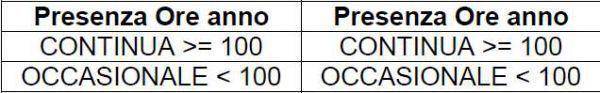
Tabella 6: livelli di esposizione del personale
Per quanto riguarda i sistemi di
allertamento, si fa sostanzialmente riferimento a sistemi di rilevazione di
sostanze esplosive (es. Rilevatori di idrocarburi o altre sostanze che posso determinare
nubi esplosive: H2S), in grado di informare tempestivamente il personale di impianto
dell’insorgenza del pericolo, accompagnate ad opportune procedure di comportamento,
da seguire in tali situazioni.
A questo punto si hanno tutti gli
elementi a disposizione per stabilire l’accettabilità o meno del rischio,
combinando: indice di esplosività E, sistemi di allertamento, esposizione del personale,
secondo quanto illustrato nella tabella 7:

Tabella 7: criteri di accettabilità del rischio
in cui si considera il rischio di
esplosione corrisponde ad Accettabile quando il rischio per le persone è basso,
le misure in essere sono idonee ed occorre solo garantire il mantenimento di
questa condizione. Nel caso di rischio Tollerabile, si ha sempre un rischio
basso per le persone, ma si richiede l’attuazione di un piano di miglioramento,
nel caso in cui il rischio risulti non accettabile, sono necessarie azioni di
risanamento urgente. Per piano di miglioramento, si intende l’instaurazione di
azioni finalizzate al
perseguimento dei seguenti
obbiettivi:
- prevenire la formazione di
miscele esplosive,
- evitare l’accensione di
atmosfere esplosive,
- attenuare gli effetti di una
esplosione.
Evidentemente le misure
indirizzate a prevenire la formazione di atmosfere esplosive sono da preferire
rispetto alle altre, come anche specificato dall'art. 289 comma 1 e 2 del
D.lgs 81/08).
2.2 Valutazione dell’efficacia delle sorgenti di innesco. Le superfici
calde
Come specificato nel precedente
paragrafo, l’analisi dei rischio di
esplosione passa dall’individuazione delle sorgenti di innesco. Un
documento che consente di raggiungere la conformità alla direttiva 99/92/CE è
la norma armonizzata UNI EN 1127-1, in cui è riportato un elenco di possibili
sorgenti di innesco, per ciascuna delle quali va valutata la sussistenza e
l’efficacia, ovvero occorre valutare se la sorgente di innesco può attivarsi e con
quale probabilità questa evenienza può verificarsi.
Nel caso delle attrezzature a
pressione, trattandosi di apparecchiature fisse di processo, non presentando
parti in movimento, le uniche sorgenti di innesco ad esse associate sono originate
dall’elettricità statica, dai fulmini o da superfici calde. Il primo caso viene
scongiurato grazie alla presenza dell’impianto di terra, mantenuto efficiente a
cura dell’utilizzatore e soggetto a verifiche periodiche da parte di un ente
terzo in accordo al DPR 462/2001. Anche il sistema di protezione contro i
fulmini viene mantenuto efficiente e soggetto alle stesse verifiche periodiche
del sopra citato DPR.
È inoltre evidente che eventuale
strumentazione elettronica, dispositivi elettromeccanici (agitatori,
miscelatori etc.) sono essi stessi forniti con opportuni modi di protezione
idonei alla zona di utilizzo.
L’unico rischio di innesco che va
gestito può essere pertanto connesso alle superfici calde. In linea di
principio, si può affermare che la temperatura superficiale di un’apparecchiatura
a pressione dipende dal fluido in essa contenuto ed è quindi strettamente
correlata al processo nel quale l’attrezzatura si trova a funzionare. Il documento
di Protezione Contro le Esplosioni, essendo che consente una valutazione globale
del luogo a rischio di esplosione, rappresenta quindi una modalità gestionale particolarmente
idonea per questo tipo di valutazione.
Una volta definita la
classificazione dell’area, indicata tramite una classe di temperatura, può
essere utile considerare nello specifico la sostanza che determina la
classificazione dell’aria e quindi la corrispondente la temperatura di accensione.
Questa infatti può trovarsi tra due classi di temperatura ed apportare dei
vantaggi nella successiva quantificazione del rischio.
Ad esempio, un’area
caratterizzata dalla presenza delle seguenti sostanze:
- Idrogeno solforato, IIA, Temp.
Accensione = 260°C;
- GPL, IIB, Temp. Acc= 365°C;
- Benzina, IIA. Temp. Acc=
>260°C;
darebbe luogo a una
classificazione corrispondente a IIBT3. La temperatura T3, corrispondente a
200°C, è determinata dalla presenza dell’Idrogeno solforato, che tra quelli
presenti è il fluido a temperatura di accensione inferiore.
Nel caso in cui si va a valutare
l’efficacia di una sorgente di innesco da superficie calda dovuta alla presenza
di un’apparecchiatura installata in questa area classificata, il limite da considerare
non è quindi 200°C, bensì 260°C, ovvero l’effettiva temperatura di accensione
della miscela esplosiva. Va inoltre specificato che, a favore della sicurezza, queste
temperature sono riferite all’80% del LEL (low explosivity level).
Definita la temperatura di
riferimento, occorre valutare presenza ed efficacia di sorgente di innesco da
superficie calda. A tale scopo, di grosso aiuto è standar API RP-2216: Ignition
Risk of Hydrocarbon Liquids and Vapors by Hot Surfaces in the Open Air (3°
edizione – Dicembre 2003), in accorso al quale si può affermare che l’efficacia
d'ignizione di idrocarburi gassosi o liquidi da parte di superfici calde
situate all’aperto è tale solo se la temperatura della superficie è di alcune
centinaia di gradi Fahrenheit superiore a quella di autoaccensione della
sostanza coinvolta. Approssimativamente viene indicato lo scarto di 360°F,
corrispondenti a 182°C. Ai fini della valutazione della potenzialità
dell’innesco da parte di una superficie calda, sempre a favore della sicurezza,
si fa riferimento a uno scarto di temperatura inferiore, pari a 105°C, tra
l’altro suggerito anche dall’American Institute of Chemical Engineers.
Una superficie calda, situata
all’aperto, può essere pertanto considerata coma una sorgente di innesco efficace,
qualora, a contatto con una determinata sostanza, si trovi a una temperatura di
105°C superiore alla temperatura di accensione di tale sostanza.
Queste considerazioni tecniche
consentono una gestione del rischio su molte apparecchiature con temperature di
esercizio superiori alla temperatura di riferimento della classe T3 (200°C),
che solitamente caratterizza la classificazione atex in numerosi impianti di
una raffineria di petrolio.
2.3 Considerazioni sulla persistenza della sorgente di innesco
Nei principi di definizione del
rischio di esplosione, abbiamo visto come la probabilità di innesco incida nel
calcolo dell’indice di Esplosione e quindi direttamente sulla quantificazione
del rischio di esplosione. Considerazioni di questo tipo sono certamente applicabili
anche su attrezzature a pressione, qualora si tenga in debita considerazione la
tipologia del processo nel quale sono inserite.
A titolo di esempio, in questa
casistica possono rientrare alcuni processi di idrodesolforazione, che
sfruttano l’utilizzo di catalizzatori per rimuovere lo zolfo legato alle molecole
di idrocarburi. In questo caso le temperature di processo, affinché le reazioni
previste avvengano con il rendimento richiesto, richiedono un certo apporto
termico, solitamente fornito tramite forni di preriscaldo. Le temperature di
esercizio necessarie all’interno dei reattori dipendono pertanto dalla qualità
del catalizzatore adoperato e possono variare durante la vita tecnologica dello
stesso, nel senso che, quando il catalizzatore sta per divenire esausto,
occorre aumentare le temperature di esercizio.
Questa situazioni impongono, in
fase di progettazione delle apparecchiature, di prevedere dei parametri di
bollo (sia come T massima di progetto che come T di esercizio prevista) superiori
a quelle che sono le effettive temperature di esercizio delle apparecchiature,
con l’effetto che una semplice valutazione documentale, in fase di stima del
rischio, condurrebbe a considerare una persistenza della sorgente di innesco
continua e di conseguenza a un livello di rischio che potrebbe anche non essere
accettabile. Una considerazione invece più attenta del processo, accompagnata a
un monitoraggio delle temperature e ad opportune procedure di gestione,
consente una mitigazione e facile gestione del rischio. Per il monitoraggio
delle temperature di processo, possono essere facilmente considerati gli
strumenti di processo, le cui misure sono solitamente registrate dai sistemi di
controllo (DCS). Inoltre, questa metodologia, può essere accompagnata da una
preventiva valutazione delle temperature superficiali dell’apparecchiatura in
esame, da eseguirsi ad esempio con tecniche termografiche, che consente anche
di stabilire un certo scarto superficiale tra la temperatura del fluido di
processo (interno all’apparecchio) e la temperatura esterna (di pelle)
dell’apparecchiatura, solitamente inferiore rispetto la temperatura del fluido
interno. Inoltre in questo modo è possibile circoscrivere il rischio di innesco
solo alle porzioni effettivamente calde di superficie dell’apparecchio in
esame.
Stabilita quindi la corrisponde
tra temperatura esterna ed interna, si possono impostare dei valori di
riferimento delle temperature di processo, in corrispondenza delle quali la temperatura
superficiale dell’apparecchiatura può determinare una sorgente di innesco efficace.
La ripetibilità di tale evento, se comporta nella definizione del rischio una situazione
Non Accettabile, o Tollerabile, richiede l’implementazione di azioni per la mitigazione
del rischio.
Anche questo tipo di azione,
implicando la valutazione globale del processo di un determinato impianto,
trova la sua naturale collocazione nel DPCE, redatto dall’utilizzatore (datore
di lavoro).
2.4 Misure per la riduzione del rischio di esplosione: sistemi di
allertamento e inertizzazione
Nel caso in cui la persistenza
della superficie ad una certa temperatura sia continua e la temperatura
superficiale (di pelle) sia tale per cui siamo in presenza di un innesco efficace,
per la mitigazione del rischio non si può più agire sulla frequenza della
sorgente di innesco, in quanto questa è continua. Occorrono delle misure più
strutturate, affinché si eviti la formazione dell’altro elemento che determina
l’esplosione, ovvero l’atmosfera esplosiva.
Spesso non è possibile agire
sulle sorgenti di emissione, a meno di non intraprendere soluzioni drastiche
come l’eliminazione di sorgenti di emissione (ad esempio sostituendo connessioni
flangiate con giunti saldati). È possibile però realizzare dei sistemi di monitoraggio,
ovvero sistemi di rilevazione gas, in prossimità delle superfici più calde dell’apparecchio,
in grado di segnalare tempestivamente la presenza di un’atmosfera esplosiva
nelle vicinanze del possibile punto di innesco e consentire l’attivazione di un
sistema di inertizzazione, che può avere il duplice effetto sia di diluire la
nube di gas (allontanandone la concentrazione dal LEL), sia di raffreddare la
superficie calda.
L’attuazione di questo tipo di
misure comporta evidentemente l’opportuno aggiornamento delle procedure
organizzative e, nel caso siano richieste delle determinate azioni da parte del
personale operativo, vanno debitamente integrate nel manuale operativo
d’impianto.
2.5 Misure attenuare gli effetti di una esplosione
Sebbene questa soluzione possa
essere perseguita per attrezzature elettriche (es. tipi di protezione con
custodie antideflagranti), certamente non può essere applicata per un’apparecchiatura
a pressione, sia per l’elevata energia in gioco, sia per le conseguenze comunque
disastrose derivanti dall’esplosione di un’apparecchiatura a pressione, che per
definizione immagazzina un’elevata quantità di energia elastica, a maggior
ragione se contenente fluidi infiammabili.
3. Valutazione del rischio di esplosione in fase di fabbricazione
Fermo restando gli obblighi
dell’utilizzatore (o datore di lavoro) di un’apparecchiatura a pressione, nella
valutazione del rischio di esplosione, il Fabbricante che deve immettere sul
mercato l’apparecchio è tenuto a una valutazione dei rischi in accordo alla direttiva Atex
94/9/CE, valutandone l’applicabilità e fornendo, analogamente a quanto viene
svolto nell’ambito della direttiva PED sulle attrezzature a pressione, un
manuale d’uso e una valutazione dei rischi Atex. Pertanto, in funzione
dell’area in cui è destinata ad essere installata l’apparecchiatura, va
valutata la presenza e l’efficacia di sorgenti di innesco, in accordo alla UNI
EN 1127-1, riconducibili al funzionamento dell’apparecchio stesso.
Questo tipo di analisi dei
rischi, può anche condurre alla conclusione che l’apparecchiatura non presenta
sorgenti di innesco proprie e che quindi non rientra nel campo di applicazione
della Direttiva Atex. In questo caso vengono fornite, nel manuale d’uso Atex,
delle raccomandazioni per un corretto utilizzo (es. mantenimento efficienza impianto
di messa a terra, valutazione del rischio di fulmini, etc.). Queste valutazioni
vanno incluse nel fascicolo tecnico dell’apparecchiatura e possibilmente richiamate
nel DPCE.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1306 volte.
Pubblicità