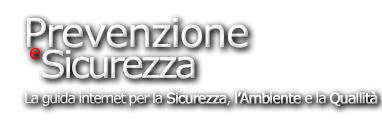News
"Rischio rumore: gli strumenti per la misurazione e le incertezze"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio Rumore
09/03/2016 - In diversi articoli del nostro giornale abbiamo affrontato, con riferimento al D.Lgs. 81/2008 e alle novità del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, il tema della
valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rumore e, nel caso di valutazione con misurazioni, le possibili strategie di misura.
Ci soffermiamo invece oggi su un aspetto operativo:
quali sono gli strumenti per la misurazione?
Per rispondere a questa domanda
riportiamo alcune indicazioni tratte dalla pubblicazione del Dipartimento
Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti
Antropici (DIT) dell’Inail dal titolo “ La
valutazione del rischio rumore”. Un documento curato da Raffaele Sabatino
(DIT), con la collaborazione di Michele Del Gaudio (Inail Unità Operativa
Territoriale di Avellino) e la revisione scientifica di Pietro Nataletti (Inail
Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale).
Riguardo alle “
strumentazioni di misura” il documento presenta
i
misuratori personali dell'esposizione
sonora, i “
dosimetri”.
Questi misuratori fissati sulla
persona “sono da utilizzare nei casi in cui non sia possibile misurare
l'esposizione di un lavoratore con il fonometro, ad esempio, quando il rumore da valutare
presenta caratteristiche di variabilità ed imprevedibilità, oppure quando non è
possibile effettuare una fonometria con un fonometro portato a mano (ad esempio
all'interno di cabine di conducenti macchine industriali); essi debbono essere
conformi alla norma CEI EN 61252/A1:2001 e rispettare i requisiti della classe
1 o 2 in conformità alla norma CEI EN 61672-1:2014 previsti per i fonometri
integratori” (si segnala che la norma CEI EN 61672-1:2003 rimane applicabile
fino al 4 novembre 2016).
In particolare il microfono viene
“montato sulla spalla, dal lato dell'orecchio più esposto, ad una distanza di
almeno 10 cm dall'apertura del canale uditivo e ad una distanza di circa 4 cm
sopra la spalla stessa”. E la misura “deve essere presenziata dal tecnico per
evitare eventuali errori sistematici dovuti a segnali non attinenti la
lavorazione specifica, o segnali dovuti a malfunzionamento delle macchine o a
un comportamento non corretto del lavoratore. In alternativa, si può ricorrere
a strumenti che consentano la registrazione della
time-history del segnale e/o della registrazione audio, per
effettuare la correzione dei dati in post elaborazione”.
Nel documento si parla anche dei
calibratori, apparecchi che emettono,
ad una frequenza stabilita, “un suono calibrato con un livello noto in dB”. La
calibrazione acustica dell'intera catena di misura mediante il calibratore “viene
effettuata prima e dopo ogni serie di misurazioni, con la stessa configurazione
strumentale, nelle stesse condizioni microclimatiche e comunque all'inizio ed
alla fine della giornata dei rilevamenti. Se, a seguito della calibrazione, lo
strumento mostra uno scostamento dal valore di taratura del calibratore di
oltre 0,5 dB, i risultati ottenuti dopo la precedente calibrazione sono
considerati non validi”.
Il secondo strumento su cui si
sofferma il documento Inail è il
fonometro
integratore.
Il fonometro, adoperato per le
misure di livello
sonoro, è “composto da un microfono, da una unità di trattamento e da una
unità di lettura dati. I fonometri integratori debbono rispettare i requisiti
della classe 1 o 2 in conformità alla norma CEI EN 61672-1:2014”.
Il documento, che vi invitiamo a
leggere integralmente, si sofferma su vari aspetti tecnici e ricorda le risposte
caratteristiche del rilevatore.
Si segnala poi che se i fonometri
più semplici “danno la misura del livello istantaneo del rumore”, esistono “strumenti
più complessi che elaborano questa misura per fornire:
- il livello equivalente LAeq
(fonometri integratori);
- l'analisi del rumore alle varie
frequenze (analizzatori in bande di ottava e 1/3 ottava);
- l'analisi statistica;
- l'analisi di evento;
- le analisi architettoniche:
tempo di riverbero RT60 e perdita di trasmissione attraverso parete”.
Ricordiamo che il LAeq è
il livello continuo equivalente ponderato e il tempo di riverberazione è il
tempo in secondi occorrente affinché il livello di pressione sonora ad una data
frequenza e posizione si riduca di 60 dB rispetto al livello iniziale dopo l’interruzione
dell’emissione sonora.
Il documento si sofferma anche
sui
rilievi fonometrici.
Infatti preliminarmente
all'esecuzione delle indagini fonometriche “occorre acquisire tutte le
informazioni atte a fornire un quadro completo delle attività pertinenti ai
lavoratori o alle postazioni cui le misurazioni stesse si riferiscono. Occorre,
pertanto, considerare:
- i cicli tecnologici, le
modalità di esecuzione delle fasi lavorative, i mezzi e ed i materiali
utilizzati;
- la variabilità delle
lavorazioni;
- le caratteristiche del rumore:
costante, fluttuante, impulsivo, ciclico;
- le condizioni acustiche in
prossimità dei punti di misura, compresa la presenza di segnali di avvertimento
e/o allarmi;
- le postazioni di lavoro
occupate e i tempi di permanenza nella stesse;
- le eventuali pause o periodi di
riposo e le relative postazioni o ambienti dove sono fruite;
- l'eventuale presenza di gruppi
di lavoratori acusticamente omogenei”.
Inoltre i rilievi fonometrici
vanno effettuati nelle “seguenti condizioni operative:
- ambienti a normale regime di
funzionamento;
- attrezzature in condizioni
operative di massima emissione sonora”.
Ricordando che la pubblicazione
Inail si sofferma anche sulla taratura delle strumentazioni e sulla misurazione
del rumore impulsivo (un rumore caratterizzato da una rapida crescita e da un
rapido decadimento della pressione sonora), diamo qualche breve informazione
sulle
incertezze.
Il documento indica che si definisce
“
incertezza” quel “parametro
associato al risultato di una misurazione, o di una stima, di una grandezza che
ne caratterizza la dispersione dei valori ad essa attribuibili con ragionevole
probabilità”. Ed infatti l'art. 190, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 prevede che il
datore di lavoro tenga conto “dell'incertezza delle misure determinate secondo
la prassi metrologica”. E dunque la corretta
valutazione delle incertezze di misura è “parte integrante della
documentazione a supporto della valutazione
del rischio”.
Concludiamo segnalando che il
documento riporta precise indicazioni relative a:
- Calcolo dell'incertezza estesa
U(LEX.8h) secondo la norma UNI EN ISO 9612:2011;
- Calcolo dell'incertezza
combinata standard - strategia basata sui compiti;
- Calcolo dell'incertezza sul
livello sonoro di picco, Lpicco;
- Calcolo dell'incertezza per
l'esposizione settimanale;
- Calcolo dell'incertezza
combinata standard - strategia basata sulle mansioni;
- Calcolo dell'incertezza
combinata standard - strategia a giornata intera;
- Gestione dell'incertezza estesa
U(LEX.8h) secondo la norma UNI 9432:2011.
Inail - Dipartimento Innovazioni
Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici, “ La valutazione del rischio rumore”, documento curato da
Raffaele Sabatino (DIT), con la collaborazione di Michele Del Gaudio (Inail
Unità Operativa Territoriale di Avellino) e la revisione scientifica di Pietro
Nataletti (Inail Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed
Ambientale), edizione 2015 (formato PDF, 8.03 MB).
Vai all’area riservata agli
abbonati dedicata a “ Valutazione del rischio rumore”.
RTM
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1119 volte.
Pubblicità