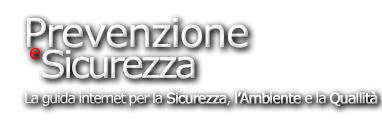News
"Linee Guida: valore giuridico e vincolatività"
fonte www.puntosicuro.it / Linee Guida
24/03/2016 -
Il Decreto Legislativo 81/08 ha
introdotto, all’articolo 2, le definizioni di tre fonti di grande
rilevanza in ambito prevenzionistico per gli RSPP, i Medici Competenti,
gli RLS, i datori di lavoro e in generale tutti gli operatori della
salute e sicurezza sul lavoro, ovvero le “
linee guida”, le “
norme tecniche” e le “
buone prassi”.
Sul valore giuridico delle norme tecniche ci siamo già soffermati in un precedente contributo (“ Norme tecniche: valore giuridico e vincolatività”, pubblicato su Puntosicuro il 29 maggio 2015).
Con
particolare riferimento ora alle
linee
guida, queste sono definite dal Testo Unico quali
“atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa
in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni,
dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni”.
(Art. 2 c. 1 lett. z) D.Lgs.81/08)
Dunque questa
definizione pone alcuni punti fermi, prevedendo che le linee guida:
consistano in
“atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa
in materia di salute e sicurezza”
per essere definite e considerate tali, debbano
essere predisposte dai ministeri, dalle regioni e dall’INAIL (v. legge 30
luglio 2010 n. 122 che ha trasferito le competenze dell’ISPESL all’INAIL)
debbano essere approvate in sede di Conferenza
Stato-Regioni.
Una prima
conseguenza che possiamo trarre da questa definizione è che non tutti gli atti
di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di
salute e sicurezza possono essere definiti “linee guida”, ma solo quelli che
vengono emanati dai soggetti su indicati e con i requisiti visti.
Per garantire
la
certezza del diritto, infatti, il
legislatore nel 2008 ha previsto che potessero intendersi quali “linee guida”
solo gli atti di indirizzo emanati da una rosa di organismi appartenenti al
sistema pubblico cui la legge ha riconosciuto l’autorevolezza e la
legittimazione istituzionale necessaria ad emanare indirizzi unitari e quindi
ad uniformare gli orientamenti applicativi per tutti gli operatori del settore.
Le linee
guida sono spesso richiamate direttamente dal D.Lgs. 81/08 e più in generale
dalla normativa prevenzionistica.
A mero titolo di esempio (perché
guardando al Testo Unico e norme correlate gli esempi potrebbero essere molti),
in materia di attrezzature di lavoro, la Relazione di accompagnamento al decreto
correttivo 106/09 specificava a suo tempo che
“all’articolo 71 [del D.Lgs.81/08] sono operate una serie di modifiche
che evidenziano
la rilevanza della
informazione, della formazione, dell’addestramento,
delle linee guida e delle buone prassi ove si verta in materia di
utilizzo di attrezzature di lavoro” e che tale articolo 71 - come risulta
anche dalla versione attuale - è stato
“cambiato
imponendo al datore di lavoro
di considerare, nell’adempimento dell’obbligo
in parola, i documenti indicati o
le
indicazioni derivanti da norme tecniche, buone prassi o
linee guida
assicurando un migliore
livello di tutela.” (il riferimento è all’attuale comma 8 dell’art.
71 D.Lgs. 81/08, cui si rinvia).
In questo caso, così come in
tutti i casi analoghi, è il legislatore stesso a richiamare espressamente e ad
imporre in maniera vincolante al datore di lavoro l’applicazione delle linee
guida.
Non va però dimenticato che le
linee guida assumono un valore giuridico anche quando queste non sono
richiamate direttamente dalla normativa prevenzionistica (es. dal D.Lgs.81/08),
ai sensi dell’art.2087 del codice civile
che pone il principio della cosiddetta “massima sicurezza tecnologicamente
fattibile”, alla luce del quale, come ci ricorda la giurisprudenza,
“in materia di sicurezza del lavoro il
datore di lavoro
è tenuto ad
uniformarsi alla
migliore scienza ed
esperienza del momento storico in quello specifico settore; e, nel caso in
cui per i suoi limiti individuali non sia in grado di conoscere la miglior
scienza ed esperienza, consapevole di tali limiti, deve avere l’accortezza di
far risolvere da altri i problemi tecnici che non è in grado di affrontare
personalmente” (Cass. Penale, Sez. IV, 16 giugno 1995 n. 6944).
Oltre ad esprimere il principio
su ricordato, l’ articolo 2087 c.c. svolge anche un’altra
importante funzione che può correlarsi anche alle linee guida, fungendo infatti
da
“norma di chiusura del sistema
antinfortunistico”, nel senso che la giurisprudenza ritiene che il datore di
lavoro non abbia assolto i suoi obblighi in materia di salute e sicurezza sul
lavoro quando, pur avendo osservato tutte le prescrizioni specifiche in
materia, non abbia adottato tutte le misure rese necessarie da particolarità
del lavoro,
esperienza e tecnica.
Secondo la Cassazione, infatti,
“l’eventuale silenzio della legge sulle
misure antinfortunistiche da prendere non esime il datore di lavoro da
responsabilità se, di volta in volta, la particolarità del lavoro, l’esperienza
e la tecnica sono in grado di suggerirgli e, quindi, di imporgli idonee misure
di sicurezza” (Cass. IV, Sent. n. 2054 del 3 marzo 1993)
.
Una interessante pronuncia della
Cassazione emanata quest’anno (Cassazione Civile, Sez. Lav., 5 gennaio 2016 n.
34) sottolinea a tal proposito che con riferimento alle misure cosiddette
“innominate” imposte dall’articolo 2087 c.c., grava sul
“datore di lavoro l’onere di provare l’adozione di comportamenti
specifici che,
ancorché non risultino
dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze
sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati
oppure trovino riferimento in altre fonti analoghe (vedi, per tutte: Cass.
2 luglio 2014, n. 15082; Cass. 25 maggio 2006, n. 12445).”
Un
riferimento implicito all’ articolo 2087 c.c. e ai principi su illustrati è
contenuto peraltro anche nella normativa specifica, laddove il Decreto 81/08
definisce la “prevenzione” come
“il
complesso delle disposizioni o misure necessarie
anche secondo la
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica
, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della
salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.” (Art. 2
c. 1 lett.n) D.Lgs.81/08)
A questo
punto, approfondiamo un po’ più in dettaglio in cosa consistano
il valore giuridico e la vincolatività
delle linee guida.
La
giurisprudenza lo illustra in maniera chiara.
Una
interessante pronuncia (Trib. Asti, 22 ottobre 2010) in tema di malattie
professionali ci ricorda, infatti, che
“nelle linee guida è normalmente contenuta
la più compiuta e particolareggiata indicazione del sapere scientifico di un
determinato settore.
Da ciò consegue che
nei processi per reati colposi (soprattutto quelli in campo medico) le
linee guida vengono spesso in rilevo, poiché da esse possono essere tratti
sia elementi indispensabili
per
l’individuazione del comportamento corretto da seguire e sia il “modello di
agente” .
Secondo tale
sentenza,
le linee guida
“costituiscono, al contempo,
fonte
dell’obbligo di adeguamento e metro della diligenza richiesta a chi opera
in un determinato settore.”
Nel caso di
specie oggetto di questa sentenza, in cui si giudicavano le responsabilità
connesse all’insorgere (prima del 2008) di varie malattie professionali
collegate alla sindrome da sovraccarico biomeccanico, il Tribunale trae -
dalla premessa su riportata relativa alla funzione delle linee guida - la
conclusione che nella fattispecie
“i medici competenti, i datori di lavoro ed
i consulenti
di questi ultimi
erano senz’altro tenuti alla conoscenza
delle linee guida relative al metodo OCRA per organizzare al meglio il
lavoro in strutture imprenditoriali aventi ad oggetto lavorazioni a rischio, in
quanto estrinsecantesi in movimenti degli arti superiori ad elevata
ripetitività.
Si deve dunque ritenere provato il nesso di
causalità tra le omissioni del medico competente e l’insorgenza delle malattie:
è ragionevole ritenere che se il medico competente avesse correttamente posto
in essere il comportamento doveroso a lui spettante in forza delle norme
nonché in forza alle regole di esperienza
e se avesse dunque agito con perizia, diligenze e prudenza nello svolgimento
del proprio lavoro, le malattie muscolo scheletriche non sarebbero insorte.”
Con
particolare riferimento al Medico Competente, va anche ricordato che ai sensi
del Testo Unico questi è tenuto a programmare ed effettuare la sorveglianza
sanitaria
“tenendo in considerazione gli
indirizzi scientifici più avanzati” (art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs.81/08).
Riguardo alla
figura del
Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, inoltre, la giurisprudenza valorizza con sempre
maggiore attenzione l’importanza che questi svolga
“
in autonomia,
nel rispetto
del sapere scientifico e tecnologico, il compito di informare il datore
di lavoro e di dissuaderlo da scelte magari economicamente seducenti ma
esiziali per la sicurezza.” ( Cassazione Penale, Sez. Unite, 18 settembre 2014 n. 38343,
caso Thyssenkrupp).
Al di fuori
dell’ambito specifico della salute e sicurezza sul lavoro, poi, ma restando in
campo medico in generale, può essere utile fare un brevissimo cenno alla norma
contenuta nell’articolo 3 della Legge 8 novembre 2012 n.189 che disciplina la
“responsabilità professionale dell'esercente
le professioni sanitarie” e che prevede che
“l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della
propria attività
si attiene a linee
guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde
penalmente per colpa lieve. […]”
Ma torniamo,
per concludere il ragionamento, alle linee guida in materia di salute e
sicurezza e alle
indicazioni
giurisprudenziali.
Se la
giurisprudenza, come abbiamo visto, rintraccia l’utilità delle linee guida nei
processi per reati colposi per infortuni o malattie professionali nel fatto che
“in esse possono essere tratti sia
elementi indispensabili per l’individuazione del comportamento corretto da
seguire e sia il “modello di agente””, allora dobbiamo domandarci a questo
punto cosa sia questo modello di agente, di colui che agisce, e quale funzione
svolga ai fini delle responsabilità
.
Ciò ci viene
chiarito, tra le altre, da una importante sentenza (Cassazione Penale, Sez. IV,
3 maggio 2010, n. 16761), che sottolinea che
“la giurisprudenza e la dottrina dominanti si rifanno a criteri che
rifiutano i livelli di diligenza ecc. esigibili dal concreto soggetto agente
(perché in tal modo verrebbe premiata l'ignoranza di chi non si pone in grado
di svolgere adeguatamente un'attività pericolosa) o dall'uomo più esperto (che
condurrebbe a convalidare ipotesi di responsabilità oggettiva) o dall'uomo
normale (verrebbero privilegiate prassi scorrette) e si rifanno invece a quello
del
cd. “agente modello” (homo
ejusdem professionis et condicionis),
un
agente ideale in grado di svolgere al meglio, anche in base all'
esperienza
collettiva, il compito assunto evitando i rischi prevedibili e le conseguenze
evitabili.
Ciò sul presupposto che se un soggetto
intraprende un'attività, tanto più se pericolosa, ha
l'obbligo di acquisire le conoscenze necessarie per svolgerla […].
Si parla dunque di
misura “oggettiva” della colpa diversa dal concetto di misura
“soggettiva” della colpa.”
Dunque,
conclude la Cassazione,
“il parametro di
riferimento non è quindi ciò che forma oggetto di una ristretta cerchia di
specialisti o di ricerche eseguite in laboratori d'avanguardia ma, per
converso, neppure ciò che usualmente viene fatto, bensì
ciò che dovrebbe essere fatto.
Non può infatti da un lato richiedersi ciò
che solo pochi settori di eccellenza possono conoscere e attuare ma, d'altro
canto, non possono neppure essere convalidati usi scorretti e pericolosi; questi
principi sono ormai patrimonio comune di dottrina e giurisprudenza pressoché
unanimi nel sottolineare
l'esigenza di
non consentire livelli non adeguati di sicurezza
sia che siano ricollegabili a trascuratezza sia che il movente
economico si ponga alla base delle scelte.”
Anna
Guardavilla
Dottore
in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali
relative alla salute e sicurezza sul lavoro
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 947 volte.
Pubblicità