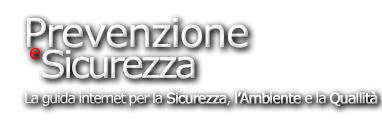News
"La prevenzione delle allergie di origine professionale"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
09/05/2016 - Sicuramente in questi ultimi anni la continua introduzione nei
settori produttivi di sostanze con potere sensibilizzante e l’evoluzione
delle tecnologie produttive hanno favorito la diffusione nei luoghi di
lavoro delle
allergopatie professionali. E se le “ sindromi allergiche professionali” non si differenziano, a livello di sintomi e, a volte, di allergeni, da quelle comuni, “perché si parli di
malattia professionale è
necessario che l’esposizione all’allergene avvenga durante lo
svolgimento dell’attività lavorativa”. Ma definire questa
contemporaneità non è facile: “la manifestazione dei sintomi non sempre
avviene durante o subito dopo la fine del turno lavorativo e l’eventuale
miglioramento degli stessi può non essere così evidente durante i
periodi di eventuale assenza dal lavoro. Il nesso tra lavoro e malattia
andrà, quindi, accertato attraverso un accurato esame della mansione
lavorativa svolta e del ciclo produttivo in cui essa si inserisce”.
A parlare in questi termini delle sindromi allergiche e del
riconoscimento come malattie professionali è uno dei contributi presenti
nella pubblicazione “ Le malattie professionali. Aspetti clinici ed assicurativi”,
curata dalla Direzione regionale Campania dell’Inail. Una pubblicazione
che raccoglie gli atti di un corso quadrimestrale di formazione sulle
malattie professionali per operatori sanitari e consulenti delle parti
che si è tenuto nel 2012 a Napoli.
L’intervento “
Malattie allergologiche di origine
professionale: il rischio specifico”, a cura di Paola Pedata (Medico del
lavoro - Dottore di Ricerca SUN), ricorda
che negli ambienti di lavoro sono state identificate “circa
300 sostanze capaci di indurre una
patologia allergica; tali allergeni sono sia forti sensibilizzanti (una
sensibilizzazione dell’organismo si può instaurare anche a seguito di
esposizione a basse dosi), sia deboli sensibilizzanti (in grado di scatenare
allergie per esposizione a livelli superiori di allergene)”.
E i lavoratori sono “esposti agli
allergeni principalmente attraverso la via inalatoria e cutanea, solo più
raramente l’esposizione avviene per ingestione”.
L’intervento riporta indicazioni
generali su diverse
tipologie di
allergeni:
-
allergeni di origine animale: ad esempio “proteine urinarie,
salivari e sieriche ma anche escrementi, piume, peli e residui cutanei”. E la
maggior parte dei casi di allergie “sono segnalate tra gli allevatori, i
veterinari, gli agricoltori, gli addetti agli stabulari e ai laboratori ma
anche tra il personale che lavora negli ambienti indoor (uffici, scuole,
abitazioni, ospedali, etc), dove la fonte principale di allergeni animali è
rappresentata dagli acari dermatofagoidi”;
-
allergeni di origine vegetale: ad esempio piante quali
“graminaceae, parietaria, cipresso, ulivo e betulla sono un’importante fonte di
allergeni in grado di provocare patologie quali asma, rinite e dermatite da contatto”. Ma altre fonti di allergeni vegetali sono rappresentate dalle
“fibre naturali (cotone, iuta, rayon, etc.) e da cereali e farine (frumento,
grano, orzo, mais, avena)”. Chiaramente presentano un maggior rischio di
sviluppare una patologia
allergica “lavoratori quali agricoltori, giardinieri, fornai, cuochi,
operai dell’industria tessile e di trasformazione del legno, etc”. Tuttavia
nell’ultimo decennio è notevolmente aumentata anche “la frequenza di
sensibilizzazioni alle proteine contenute nel lattice, dotate di elevata
attività antigenica. Tra le categorie a maggior rischio di sensibilizzazione vi
sono i lavoratori del settore sanitario, quelli addetti alla manifattura della
gomma, ai lavori domestici e i giardinieri”;
-
allergeni derivanti da funghi e batteri: se funghi e batteri
possono essere causa di patologie allergiche, tra i funghi “soprattutto le
muffe hanno un enorme potere allergizzante. Casi di allergie sono segnalati tra
i lavoratori delle industrie farmaceutiche, delle industrie che producono
biodetersivi e di quelle alimentari.
Inoltre, lavoratori quali restauratori e bibliotecari possono essere
esposti a questi tipi di allergeni”;
-
allergeni chimici: sono poi
molteplici le attività lavorative che espongono ad allergeni di origine
chimica. Infatti le allergopatie dovute a sostanze chimiche, organiche ed
inorganiche, sono “di frequente riscontro tanto nell’industria quanto
nell’artigianato e nell’agricoltura”.
L’intervento si sofferma in
particolare su diversi allergeni professionali di natura chimica - isocianati,
ossido di etilene, anidride ftalica, anidride maleica, anidride
trimellitica, parafenilendiamina,
formaldeide, amine alifatiche, ... – e riporta esempi di varie sostanze responsabili
di dermatiti allergiche tra i metalli, tra gli agenti chimici contenuti nella
gomma, tra le resine, i coloranti e gli olii.
L’intervento, che si sofferma
anche sulle caratteristiche delle allergopatie, sulla suscettibilità individuale
dei lavoratori e su vari fattori di rischio, riporta infine – oltre a dati e
osservazioni sulle criticità del riconoscimento delle malattie allergologiche –
varie indicazioni sulla
prevenzione
del rischio.
A questo proposito si indica che
la
prevenzione delle allergopatie
professionali risulta di “difficile attuazione” in quanto spesso è impossibile
“eliminare o ridurre l’esposizione agli allergeni pur effettuando il cambio di
mansione”. Senza dimenticare che se alcuni allergeni sono strettamente legati
all’ambiente professionale, “altri si trovano anche in ambiente domestico”.
In linea generale la
prevenzione si può attuare attraverso:
- la sostituzione della sostanza
a rischio;
- l’attuazione di programmi di
educazione sanitaria;
- l’applicazione di protocolli di
sorveglianza sanitaria mirati;
- l’utilizzo di idonei dispositivi
di protezione individuale.
E se l’obiettivo massimo si
ottiene “sostituendo l’agente sensibilizzante con uno che non lo è”, se ciò non
è possibile “bisogna ridurre i livelli di esposizione attraverso
l’automatizzazione delle lavorazioni, l’adozione di cicli lavorativi chiusi, il
mantenimento di idonee condizioni microclimatiche, la rotazione del personale
potenzialmente esposto, la schedatura tecnica delle sostanze e l’etichettatura
di ogni singolo componente, la formazione ed informazione degli esposti sulla
tipologia di sostanze adoperate, le prassi di lavoro sicure e il corretto
utilizzo dei dispositivi di protezione individuale”.
Inoltre, ove possibile e malgrado
alcune criticità riportate nell’intervento, la presenza di agenti
allergologici nel ciclo produttivo “deve essere quantitativamente valutata
sia nell’ambito della mansione specifica a rischio che nell’ambiente
circostante” attraverso il
monitoraggio
ambientale.
La
sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti rappresenta poi “la
fase essenziale della prevenzione secondaria; permette al Medico Competente
di verificare l’assenza di segni di malattia professionale, ovvero la presenza
degli stessi e di identificare precocemente i soggetti con incrementato rischio
di sviluppare allergopatie”.
Ed infine il
sopralluogo conoscitivo dei luoghi di lavoro rappresenta un “utile
strumento per il Medico Competente, che consente di valutare da vicino
l’ambiente lavorativo, i metodi di lavoro e, soprattutto, la gestualità insita
nella mansione”.
Inail - Direzione regionale
Campania, “ Le malattie professionali. Aspetti clinici ed assicurativi”
,
atti del I Corso Quadrimestrale Di Formazione sulle malattie professionali per
operatori sanitari e consulenti delle parti che si è tenuto a Napoli tra marzo
e giugno 2012 (formato PDF, 4.07 MB).
RTM
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1084 volte.
Pubblicità