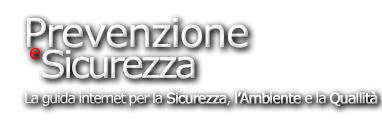News
"Sovraccarico biomeccanico e lavori ripetitivi degli arti superiori"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
31/05/2012 - l 3 aprile 2012 si è tenuto a S. Nicola
La Strada, in provincia di Caserta, un convegno dal titolo “
Sovraccarico biomeccanico degli arti
superiori”, un tema molto delicato in relazione all’incremento di casi di
patologie muscolo - scheletriche correlate a condizioni di lavoro comportanti
sovraccarico biomeccanico per il rachide e gli arti superiori, o caratterizzate
dal mantenimento di posture scorrette o dal mancato rispetto dei principi
ergonomici.
Il
convegno, i cui atti sono stati pubblicati sul sito dell’ Associazione Medici Competenti
campani (AS.ME.CO.), è stato organizzato oltre che da AS.ME.CO. anche
dall’Associazione di formazione Teseo e ha visto impegnati diversi relatori su
temi come la valutazione del rischio, con particolare riferimento al
sovraccarico biomeccanico, o su temi correlati alla sorveglianza sanitaria, al ruolo
e agli strumenti a disposizione del medico competente.
Ci
soffermiamo oggi brevemente sull’intervento “
Rischi da sovraccarico biomeccanico - lavori ripetitivi degli arti superiori”
- a cura dell’ing. Raffaele Pernicola - che sottolinea come le
patologie da sovraccarico biomeccanico siano
“definite come alterazioni delle unità osteo-muscolo-neuro-tendinee e delle
borse legate alla presenza di un costante impegno funzionale dei distretti
dell’arto superiore (spalla, gomito, mano, polso) e di altri distretti corporei
quali il rachide e le ginocchia, che se causate o aggravate da movimenti o
sforzi fisici ripetuti in ambiente lavorativo, vengono inquadrate come ‘lavoro
correlate’”.
E
per indicare le origini occupazionali di queste patologie si utilizzano vari
acronimi, ad esempio
WMSD (Work related Muscolo Skeletal
Disorders), acronimo che “sottolinea l’intervento di una causa lavorativa senza
introdurre la causa supposta (‘cumulativa -CTD- e ‘ripetitiva’ -RSI-)”. Con
riferimento agli arti superiori (upper limb) l’acronimo diventa poi UL-WMSD.
Si
ricorda poi che le patologie
da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, “a differenza delle
malattie professionali specifiche, per le quali è riscontrabile una relazione
diretta di causa-effetto tra agente nocivo e malattia, sono a
eziopatogenesi multifattoriale”.
Ci
sono cioè
fattori di carattere endogeno
(sesso, età, forza, patologie croniche, condizioni psicologiche, ...) e
fattori di carattere esogeno:
“movimenti ripetitivi, alta frequenza e velocità, impiego di forza, posture
incongrue e gesti stereotipati, durata dei cicli lavorativi, tempi di recupero
insufficienti, ritmi imposti, disergonomia delle postazioni di lavoro e degli
strumenti”. Nonché “fattori complementari, variabili col tipo di compito
lavorativo svolto, che possono fungere da amplificatori del rischio (incremento
delle condizioni di discomfort)”.
Riguardo
ai fattori esogeni esiste comunque una evidenza della “
associazione tra i principali fattori di rischio lavorativo e le
patologie UL-WMSD (distretti spalla – gomito – mano -polso)”.
A
questo punto la presentazione si sofferma sulla
normativa, con particolare riferimento al Decreto legislativo 81/2008 e alle norme
tecniche UNI ISO 11228 1-2-3, a cui si fa cenno nell’allegato XXXIII del D.
Lgs. 81/2008.
Ricordiamo
che la
UNI ISO 11228-3 fornisce una
guida sull’identificazione e valutazione dei fattori di rischio comunemente
associati alla movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza consentendo di
conseguenza la valutazione dei relativi rischi.
L’intervento
offre poi alcune
definizioni utili,
in relazione all’organizzazione di lavoro e ai fattori di rischio, per
comprendere i successivi passaggi relativi alla valutazione
del rischio.
Ad
esempio si ricorda che i
compiti
ripetitivi sono attività lavorativa caratterizzate “da cicli ripetuti
composti da azioni tecniche”, dove il
ciclo
è una “sequenza di azioni tecniche di durata relativamente breve, ripetuta per
più volte uguale a se stessa” e l’
azione
tecnica è un’azione “che comporta attività meccanica; non va
necessariamente identificata con un singolo movimento articolare, ma invece con
un complesso di movimenti di uno o più segmenti corporei che permettono il
compimento di una operazione elementare compresa in un ciclo”.
L’
approccio valutativo di rischio riportato
dalla Norma UNI ISO 11228-3, in relazione ai lavori
ripetitivi degli arti superiori, comprende
4 fasi:
-
Fase 1 – Identificazione del rischio - fattori di esposizione;
-
Fase 2 – Stima del rischio - simple risk assessment;
-
Fase 3 – Valutazione dettagliata - detailed risk assessment;
-
Fase 4 – Riduzione del rischio - riprogettazione e rivalutazione.
Il
protocollo di valutazione è il
sistema OCRA.
Rimandando
i nostri lettori ad una lettura esaustiva del documento agli atti relativo
all’intervento dell’ing. Pernicola, ci soffermiamo su alcuni punti
significativi della valutazione.
Riguardo
all’
identificazione del rischio il
metodo OCRA semplificato (check list)
“rappresenta lo strumento per ottenere la prima mappatura del rischio”.
La
check list “va utilizzata per
descrivere una postazione di lavoro e stimare il livello di rischio intrinseco
del compito svolto (fascia verde -assente-, gialla -molto lieve o dubbio-,
rossa o viola -rispettivamente lieve-medio o elevato-), come se quella
postazione fosse l’unica utilizzata per l’intero turno, al di là delle
rotazioni dei lavoratori”.
Perde
tuttavia in precisione “poiché l’analisi offre punteggi che procedono secondo
scenari a scalini temporali, non determinati in modo analitico, ma rappresenta
un ottimo strumento di prima valutazione e determinazione dell’ entità
del rischio”.
In
particolare la check-list OCRA “si compone di cinque parti, dedicate allo
studio dei quattro principali fattori di rischio (tempi di recupero, frequenza,
forza, posture incongrue, stereotipia) e dei fattori complementari,
considerando la durata netta del lavoro ripetitivo determinata dall’analisi dei
dati organizzativi. Lo schema classico di analisi del rischio prevede
l’individuazione, attraverso l’uso di valori numerici pre-assegnati (crescenti
in funzione dell’aumento del rischio) di punteggi di rischio relativi a
ciascuno dei fattori di rischio”.
E
la combinazione “dei valori dei punteggi ottenuti per ciascuno dei fattori di
rischio produce una entità numerica che consente la stima del livello di
esposizione”.
Ricordando
l’importanza di individuare i compiti lavorativi che si compiono secondo cicli
ripetuti (indipendentemente dalla loro durata), uguali a se stessi, o che
comportano la ripetizione dello stesso gesto per gran parte del tempo,
l’intervento si sofferma poi, con dovizia e supporto di immagini e disegni, su
alcuni
elementi importanti per la
valutazione come:
-
tempo netto di lavoro ripetitivo (per
determinarlo è necessario analizzare l’organizzazione del lavoro ed in
particolare: orario di lavoro e distribuzione dei turni; la presenza di pause
programmate o altre interruzioni di attività ufficiali ed effettive; presenza
di compiti lavorativi non ripetitivi);
-
tempo netto di ciclo e tempo osservato;
-
valutazione dei periodi di recupero
(“si definisce periodo di recupero quello non comportante un impegno
significativo a carico delle strutture muscolo-tendineo-articolari”): in
particolare esiste “un rapporto ottimale tra il tempo impiegato in attività lavorativa ripetitiva
e quello di recupero (pausa): 5:1. Non è quindi considerato accettabile un
periodo di lavoro con movimenti ripetitivi che si prolunghi, senza un adeguato
periodo di recupero, oltre 60 minuti. Pertanto, sulla base del suddetto
rapporto tra tempo di attività ripetitiva e pause, è necessario avere un
periodo di recupero di 10 minuti ogni ora di lavoro ripetitivo. Sono
preferibili più pause di breve durata a poche pause di durata più lunga”;
-
frequenza delle azioni;
-
valutazione delle azioni tecniche;
-
valutazione di posture e stereotipia
(“postura neutra: posizione articolare con minima attività muscolare; postura
incongrua: posizione articolare che devia dalla neutralità”): l’intervento riporta
diverse immagini esemplificative di: posture incongrue della spalla; posture
incongrue del gomito; posture incongrue del polso; posture incongrue di
mano-dita (ad esempio con riferimento alle prese pinch, caratterizzate
dall’opposizione tra il pollice e le articolazioni terminali delle altre dita, e
ad altre prese), ...;
-
mantenimento delle posture incongrue;
-
valutazione della forza: “la forza
rappresenta più direttamente l’impegno biomeccanico necessario per compiere
specifiche azioni tecniche (statiche o dinamiche), mantenere posture, movimentare
carichi, mantenere oggetti. Le posture incongrue sono responsabili spesso
della eccessiva richiesta di forza”. L’intervento si sofferma in particolare,
per la valutazione della forza, sulla
scala
di Borg;
-
valutazione dei fattori complementari
(nel processo di valutazione dell’esposizione al rischio UL-WMSD i cosiddetti
“fattori complementari” possono o meno essere presenti nell’attività
lavorativa) : sono fattori fisico-meccanici (uso di strumenti vibranti, svolgimento di lavori di precisione, esecuzione
di movimenti bruschi o a strappo, uso di DPI inadeguati, ...) o fattori organizzativi.
Al
termine dell’intervento è riportato un esempio di
punteggio finale di check-list: “per ciascun arto, sulla base dei
punteggi e moltiplicatori determinati per ciascun fattore di rischio, si
calcola il punteggio finale della check-list a cui può corrispondere un rischio
diverso ed a cui potrà essere associata una previsione percentuali di
patologici”.
“ Rischi da
sovraccarico biomeccanico - lavori
ripetitivi degli arti superiori”, a cura dell’ing. Raffaele Pernicola
(Responsabile del Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza e del Servizio di
Prevenzione e Protezione presso un’azienda produttrice di Smart Cards),
intervento al convegno dal titolo “Sovraccarico biomeccanico degli arti
superiori” (formato PDF, 2.02 MB).
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1275 volte.
Pubblicità