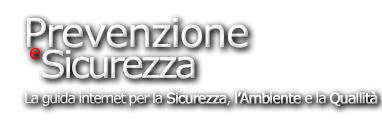News
"Prevenzione degli incidenti: meglio le regole o il ragionamento autonomo?"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio
12/04/2013 - Alcuni giorni orsono ho scritto un articolo su questa rivista on line ( Percepire i rischi e controllarli autonomamente: si può insegnare?), ottenendo una certa effervescenza di risposte. Poi Attilio Pagano ne ha scritto un altro ( Gli errori più comuni nella valutazione dei rischi),
ragionando sempre sul tema della prevenzione degli errori di
valutazione, specialmente quelli che possono essere commessi dai diretti
interessati dai rischi in oggetto che ovviamente non sono
“specialisti”.
Vorrei quindi tornare sul tema per approfondire la tematica della
base fondamentale dei comportamenti sicuri,
che vede due scuole distinte e talora apertamente contrapposte, che a
loro volta nascono da una visione della psicologia diversa:
comportamentismo e cognitivismo.
Tenete conto che io non sono uno psicologo, quindi a me interessa
raggiungere un risultato positivo rispetto ad una necessità concreta. Le
due visioni psicologiche, invece, vedono l’essere umano nella sua
interezza, e quindi giustamente le discussioni in merito sono ben che
legittime e importanti. Lo sono meno se parliamo di sicurezza e salute
sul lavoro, dove il problema e l’eventuale esito positivo sono
immediatamente riconoscibili e misurabili. Arriverò a sostenere che
entrambe le visioni e gli approcci sono corretti, ma lo sono per
situazioni diverse fra loro. E aggiungo di avere una predilezione per la
visione cognitiva, ma solo perché mette al centro la persona, la sua
intelligenza e la sua determinazione (cosa che mi è particolarmente
congeniale).
Gli errori di comportamento
Sempre da tecnico, e sempre parlando di sicurezza e salute sul lavoro, posso pensare di distinguere gli errori che portano a situazioni pericolose o a veri danni alle persone, in due categorie (molto macro):
-
errori che si manifestano in situazioni “normali”,
ovvero in situazioni che si sono già presentate e/o si presenteranno
ripetutamente al lavoratore, in una forma ben definita e “ripetitiva”;
-
errori che si manifestano in risposta a situazioni “eccezionali”, forse anche prevedibili in astratto, ma mai considerate o fatte considerare a colui che commette l’errore.
Nel
primo caso se sono addestrato e
allenato ad affrontare la situazione secondo uno schema comportamentale ben
definito, se adotto quel comportamento con disciplina, attenzione e
determinazione, allora posso immaginare di non incorrere in rischi per la
salute e la sicurezza, o di avere un tale controllo che tali rischi non si
tramutano in danni. Quindi si tratta di riconoscere una situazione nota e di
rispettare le regole stabilite.
Nel
secondo caso invece devo
necessariamente passare da un processo che parte dal riconoscimento del
problema potenziale per arrivare alla elaborazione ed attuazione delle
(eventuali) contromisure di controllo. Quindi le parole chiave sono conoscere,
valutare e decidere, ovvero termini che ci rimandano ad un comportamento
fortemente attivo da parte del soggetto interessato.
Vorrei
fare notare che NON ho citato i termini ben noti: situazioni anomale o di
emergenza. Questo perché possono ricadere anche nella prima categoria, se
previste in sede di valutazione dei
rischi,
e controbattute tramite apposite procedure su cui gli esposti sono addestrati e
allenati. C’è ovviamente un passaggio di riconoscimento della situazione non
semplice e assolutamente fondamentale, ma poi se la situazione è fra quelle
catalogate il comportamento potrà seguire regole predefinite e ben conosciute.
La prevenzione
degli errori tramite le regole
Molti
vogliono farci credere che esista una ed una unica risposta. Chi scrive non è
d’accordo, le situazioni e gli stimoli cui sono sottoposti i lavoratori sono
molteplici, e devono essere affrontati con una adeguata specificità. Questo
però comporta anche uno sforzo formativo non indifferente per coinvolgere
pienamente gli stessi lavoratori su questo approccio complesso.
Dividiamo
quindi i due approcci base che cerchiamo tutti di applicare, a diverso livello
di intensità. Non si tratta di scuole di pensiero ma di misure che nella
sostanza sono elementari. Il primo gruppo di misure è quello che potremmo
definire:
ISTRUZIONI DI SICUREZZA,
ovviamente intendendo con l’etichetta “sicurezza” anche la salute.
Una
istruzione di sicurezza nasce dalla
valutazione di una situazione pericolosa (entro il DVR) piuttosto che come
conseguenza di un mancato infortunio o di altri tipi di rilievi. Dal rilievo
del problema di sicurezza si passa allo studio di eventuali misure di controllo
del rischio, sempre che non siano possibili ben più radicali misure tecniche
che potrebbero addirittura non eliminare il pericolo ma ridurre il rischio
praticamente a zero. Se le misure possibili sono misure di controllo, di cui è
parte integrante il corretto comportamento umano, sarà opportuno
definire esplicitamente quali siano i corretti modi di operare per evitare di
subire i danni di cui si sta ragionando. Quindi nascerà una istruzione che dice
cosa fare, come farlo, quando e con quali precauzioni.
Poniamo
di dovere imbragare un tubo metallico lungo sei metri e pesante cinque
tonnellate mediante due cinghie telate a loro volta appese al gancio di un
carroponte.
Una
parte della istruzione dirà (dopo che le cinghie sono state predisposte e
agganciate al carroponte):
|
OPERAZIONE |
PERICOLI
E RISCHI |
PRECAUZIONI
E DPI |
|
… |
… |
… |
|
sollevare
il tubo di pochi centimetri |
perdita
del carico
schiacciamento
degli arti inferiori
 |
tenersi
a distanza di almeno 80 cm
 |
|
verificare
che il tubo sia ben bilanciato (deve restare orizzontale) e che le brache non
scivolino sul tubo |
perdita
del carico (anche in fasi successive se si movimenta un carico non
correttamente bilanciato)
schiacciamento
degli arti inferiori
 |
tenersi
a distanza di almeno 80 cm
qualora
il tubo fosse sbilanciato appoggiarlo immediatamente e rifare l’imbragatura
 |
|
… |
… |
… |
Dove
ovviamente la piccola verifica prescritta serve per controllare che non ci
siano problemi di stabilità del carico quando ancora il medesimo è basso e
quindi il rischio può considerarsi controllato (se anche perdessi il carico la
potenzialità di danno è limitata e diventa quasi zero se mi tengo a distanza)...
Questo
approccio, sappiamo, funziona bene per gestire situazioni oggettive di rischio,
relativamente semplici e, più che altro, ripetitive. La nostra istruzione, nei
limiti del possibile, coprirà più situazioni simili (tubi di lunghezza sino a
dodici metri, per esempio, o tutti gli elementi cilindrici a diametro costante
…).
Non
vogliamo discutere ora sulla specifica correttezza della istruzione, vorremmo
invece parlare della
efficacia delle
istruzioni.
Esistono
molteplici criticità che andiamo ad elencare:
-
la
prima deriva dal fatto che non è
pensabile che TUTTI i rischi possibili in una azienda industriale vengano
valutati. Il DVR arriverà a “vedere” quelli più macroscopici e quelli
decisamente ripetitivi, ma esisteranno sempre situazioni particolari che il DVR
non ha preso in considerazione. Questo anche se il DVR è realizzato con estrema
cura ed attenzione. Quindi in diversi casi (quanti in percentuale?) viene a
mancare il presupposto essenziale per predisporre una istruzione di sicurezza.
Prevengo subito le obiezioni: è chiaro che col tempo si migliora e si
identificano sempre più rischi, ma la completezza assoluta è un risultato a mio
avviso non raggiungibile;
-
la
seconda questione è più subdola:
la definizione delle misure di controllo non è sempre così semplice perché le
stesse misure possono essere di ostacolo eccessivo al lavoro oppure essere esse
stesse fonte di rischio. Quindi le istruzioni possono essere per loro natura
imperfette o non sempre applicabili alla realtà concreta (là dove la realtà
presenta delle varianti che in alcuni casi costringono ad operare diversamente
da come stabilito). Ora qualcuno potrebbe dire: perché le istruzioni operative
spesso son fatte male, spesso con l’intento di togliere responsabilità ai
vertici in caso di infortunio. Vero in alcuni casi, ma nel concreto il problema
esiste anche quando tutti operano al meglio e con tempo a sufficienza per
raccogliere e organizzare le informazioni;
-
la
terza è la difficoltà di
recepimento: se dovessi regolamentare tutto in modo capillare, tutto quello che
in una azienda industriale ha risvolti anche di sicurezza e salute sul lavoro,
allora verrei a creare una tale mole di istruzioni, tanto ampia da risultare
illeggibile e, di fatto, inapplicabile. Quindi esiste un problema di capienza,
più di tante istruzioni, per quanto fatte bene, non posso darne.
A
questi che sono limiti indiscutibili di un approccio di prevenzione degli
errori basato sulla “imposizione” di comportamenti sicuri, dove spero che il
termine imposizione possa essere stemperato da una fattiva collaborazione con
le persone esposte ai rischi all’atto della definizione dei comportamenti
sicuri,
se ne aggiunge un altro molto subdolo: se ho l’impressione che tutti i rischi
residui siano stati valutati e messi sotto controllo tramite regole
comportamentali, allora potrei ritenere di non aver motivo di prestare
attenzione autonoma agli aspetti di sicurezza, in quanto basta che io segua le
regole per essere sicuro. Nessun lavoratore sosterrebbe una tesi del genere, ma
a livello sub conscio come funziona?
La prevenzione
degli errori tramite il ragionamento autonomo
Sorrido
quando io stesso uso il termine “gli specialisti della sicurezza”, intendendo
con questo le persone che dedicano a questo tema la loro intera attività
lavorativa. Come se esistesse una specializzazione intesa come “studio”, quando
invece la differenza è fatta, in larga misura, dalla esperienza. Non bisogna
essere vecchi per essere esperti, però bisogna prestare tanta attenzione a
quello che ci circonda per costruirci le nostre categorie di giudizio. La
disattenzione, la distrazione dalla realtà concreta rappresentano i peggiori
nemici di chi si occupa di sicurezza.
Perché
la premessa? Per dire che non ci vuole un prerequisito particolare per potere
ragionare correttamente in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Quindi con
il giusto stimolo tutti possono farlo. Ovviamente devono volerlo fare!
Allora
non capisco mai bene perché si debba parlare ai lavoratori degli esiti della
valutazione dei rischi, invece di
insegnare
loro a fare la valutazione dei rischi.
Alcuni
giorni fa è apparso su queste pagine un bell’ articolo di Attilio
Pagano
che evidenziava come tutti noi, nella vita, siamo portati a valutare i rischi
(di qualunque natura) a cui siamo esposti. Invece, aggiungo io, sul lavoro,
forti del fatto che la nostra sicurezza e la nostra salute devono essere
tutelati dal datore di lavoro, talvolta dimentichiamo di applicare questa
nostra capacità.
Quindi
il primo passo dovrebbe e può essere di “recupero”, processo che si può
realizzare tramite una riconsiderazione dei ruoli e un semplice esame della
realtà oggettiva. I punti cardine di questo ragionamento, che deve coinvolgere
tutta la popolazione aziendale, potrebbero essere quelli che seguono:
-
chi può avere più interesse per la salute e la sicurezza di una persona se non
la persona stessa? Quindi il singolo lavoratore DEVE essere il primo attore di
tutto quanto concerne prevenzione e protezione dai rischi che corre. Questo lo
dice anche l’articolo 20 del D.Lgs. 81/2008, mettendo questo concetto per
primo; solo dopo si parla di rispetto delle leggi e delle regole aziendali;
-
per fare quanto detto è necessario che ognuno applichi la propria intelligenza
al problema. Se vale quanto detto sopra sull’essere “specialisti” di sicurezza,
allora potremmo concludere che per essere efficaci è necessario allenare la
capacità di focalizzare parte della nostra attenzione e della nostra capacità
di ragionamento sugli aspetti di sicurezza e salute che ci possono riguardare
direttamente;
-
per stimolare l’attivazione dei lavoratori su questo tema è però necessaria una
azione decisa da parte della azienda, volta principalmente al
recupero della centralità dell’individuo
nella gestione della propria sicurezza e salute, e nella riattivazione
dell’approccio naturale alla valutazione dei rischi.
A
questo proposito vorrei proporre alcuni concetti con cui arrivare alla
comprensione da parte delle persone.
Il
primo concetto da evidenziare è, ovviamente, la
incompletezza inevitabile del DVR e quindi il fatto che non tutte
le situazioni che ci si presentano davanti nel nostro lavoro sono state
preliminarmente valutate da qualcuno. E quando una situazione non valutata ci
si presenta davanti, noi non siamo accompagnati dal RSPP che immediatamente la
valuta, noi siamo soli, siamo talvolta gli unici che vedono e lì, in quel
momento, noi da soli dobbiamo decidere cosa fare. Se non riconosciamo il
rischio e se non vogliamo fare la fatica di valutarlo, potremmo procedere senza
adottare contromisure sino a procurarci un infortunio o una malattia
professionale.
E
non scordiamoci neanche il
concetto di
rischio residuo! Il rischio residuo dichiarato
accettabile in sede di DVR, non smette di essere un rischio ben concreto per le
persone. Un esempio di cui abbiamo recentemente discusso con dei lavoratori: in
un ufficio esiste il rischio elettrico. La risposta è affermativa, poi
risulterà un rischio residuo accettabile per tutte le misure adottate per
evitare contatti diretti o indiretti alle persone che lavorano in quell’ufficio.
Il
secondo punto, che discende dalla presa di coscienza che anche negli ambienti
più “tranquillizzanti” sussistono rischi per la sicurezza e la salute delle
persone, è:
quale caratteristica
intrinseca del rischio interessa di più a noi come individui?
E
qui emerge, a mio avviso, un passaggio molto importante che vorrei quasi
mettere in contrapposizione con una parte del ragionamento fatto nel già citato
articolo di Attilio Pagano. Interrogando i lavoratori si ricava che l’elemento
che più salta agli occhi fra quelli che costituiscono un rischio, è la gravità
del possibile danno. In effetti ha una sua logica: in un mondo (lavorativo e
non) dove la probabilità viene ritenuto un parametro solo teoricamente
conoscibile, ma di cui nessuno si fida, la risposta alla domanda “nel peggiore
dei casi cosa mi potrebbe accadere?” diventa lo strumento migliore per prendere
una decisione. E lo confermano anche certe paure e scelte che nulla hanno a che
vedere col lavoro: per esempio la paura del nucleare, che in termini
probabilistici sarebbe, invece, un fenomeno ben conosciuto, tale da dare un
rischio “accettabile”.
La
questione è che alcuni fenomeni a bassa probabilità (è un campo ben definito
nell’ambito degli studi affidabilistici per la sicurezza dei grandi impianti
industriali), vengono trattati come fenomeni a probabilità ignota, e quindi
passano davanti in termini di rischio, ad altre casistiche meno gravi ma assai
più probabili.
Nulla
di grave, in pratica, sono errori legati a forti paure insite nella nostra
cultura a cui rispondiamo con alti livelli di ansia. Io credo che si possa
ammettere questa falla del ragionamento implicito piuttosto che cercare di
vincerla con ragionamenti che rischiano di essere fuorvianti nella
determinazione di una strategia delle scelte.
Sembra
contorto? Non lo è, provo a ricapitolare con lo stesso flusso logico che uso
quando cerco di
convincere i lavoratori
ad “usare” la valutazione dei rischi:
-
provate a chiedere: “Che sensazione provate se vi tagliate lievemente con il
bordo di un foglio di carta che state prendendo dalla stampante? È una
esperienza comune a molti. Come reagite? È un problema?”; la risposta è “No,
non è un problema!”, oppure è “Sono cose che capitano …”. Se invece per
tagliare a misura lo stesso foglio usate una taglierina manuale e vi amputate
la prima falange dell’indice della mano sinistra, come reagite? La risposta è
molto diversa, piena di ansia e preoccupazione. Allora evidentemente noi
abbiamo maggiore propensione a mettere in atto contromisure quando
capiamo che un determinato
pericolo/rischio può causarci danno di una certa entità, superiore a una soglia
predefinita che abbiamo in testa (e che per ognuno è diversa). Se è così,
essendo noi “azienda” particolarmente interessati a ridurre i danni gravi o
gravissimi, possiamo ragionevolmente contare che un atteggiamento del genere
vada nella direzione giusta generando un “aiuto” alla salute e alla sicurezza
da parte dei lavoratori;
-
avrete notato che sopra ho sottolineato la parola “capito”, che considero un
sinonimo di visto, riconosciuto, ovvero del fatto che ci siamo resi conto
coscientemente e pienamente di una situazione in essere vicino a noi (di un
pericolo/rischio). Se non vediamo è ovvio che non facciamo nulla, ovvero non
abbiamo motivo di adottare contromisure. Quindi la abitudine a “guardarsi
intorno” è determinante e deve essere stimolata e anche premiata (premiare chi
segnala situazioni pericolose concrete).
Se
davvero riuscissimo nel nostro intento la sicurezza sui luoghi di lavoro vedrebbe
un nuovo drammatico (in senso positivo) miglioramento. Ricordiamoci che l’INAIL
sostiene che circa due terzi degli infortuni hanno fra le cause gli errori umani; quindi se
rimuovessimo gli errori umani ridurremmo davvero tanto gli infortuni.
Se
la soluzione appare, a mio modesto avviso, piuttosto elementare, metterla in
atto non è semplice, e ancor meno immediato. Infatti quello che si richiede ai
lavoratori è un profondo cambiamento di mentalità in direzione contraria
rispetto a quella che è la consueta concezione del lavoro.
Il
concetto proposto si potrebbe tradurre in:
passare
dalla concezione della sicurezza come diritto alla concezione della sicurezza
come dovere personale. Senza polemiche, davvero, qui c’è un concetto che va
contro tutta la storia sindacale nazionale.
Però
questo non deve essere un problema, la strada da percorrere è inevitabile. Il
vero problema sono gli strumenti e i tempi.
Un
caro amico mi richiamava alla realtà quando ero molto più giovane, dicendomi:
se quello che vuoi ottenere è il cambiamento della mentalità diffusa in una
azienda, allora pensa ad un periodo necessario di alcuni anni, diciamo cinque
anni per un cambiamento vero e profondo. Devo riconoscere che aveva ragione, ci
siamo impegnati insieme in un progetto parecchio ambizioso, proprio su
sicurezza e salute, e il cambiamento ha cominciato ad apparire dopo un paio di
anni ed è diventato sostanziale (e rispondente agli obiettivi) dopo circa
cinque anni.
Ok,
i tempi, ma gli
strumenti? A mio
avviso, per quel poco che posso capire, sono due: spiegare la logica di fondo
(anche con esempi) ripetutamente nel corso del tempo e fare esempi in campo,
come si dice
on the job. Insomma:
tanta pazienza e dedizione! Ma anche tanta convinzione di essere davvero nel
giusto! Convinzione che dovrà essere trasmessa ai lavoratori.
Ieri
un amico mi faceva osservare che chiunque, indipendentemente dal grado di
istruzione e dalla esperienza specifica, è in grado, se si applica, di
sviluppare i ragionamenti necessari per tutelare la propria sicurezza e la
propria salute sul luogo di lavoro. È stata una piacevole condivisione di
quello che stavo appunto scrivendo.
L’approccio
sinergico e la centralità della persona
Spero
non sembri una brutta parola. Quello che intendo rimarcare è la convinzione che
non esista un sistema unico e completo, che risolva il problema dei comportamenti umani in relazione alla
sicurezza e alla salute sul lavoro. Peraltro vale la pena osservare che
l’individuo è l’elemento singolarmente più complesso che possiamo trovare in un
ambiente lavorativo (altro che impianti), e che poi una “comunità” di persone
sono un qualcosa di ulteriormente complesso. Sarebbe strano che a situazioni
complesse si potesse rispondere con soluzioni semplici.
Quindi
dobbiamo mettere in campo più risposte, ognuna delle quali preferibilmente
semplice da attuare, e gestirle in modo sinergico coinvolgendo al massimo grado
tutti i lavoratori non solo sotto il profilo applicativo, ma anche nella
comprensione della strategia generale di prevenzione adottata dalla azienda.
Che
questo sia poi un approccio che rivaluta la
centralità della persona anche in questi processi legati alla
salute e alla sicurezza sul lavoro è aspetto che a chi scrive piace molto, ma
queste sono davvero opinioni e visioni etiche del tutto personali.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1270 volte.
Pubblicità