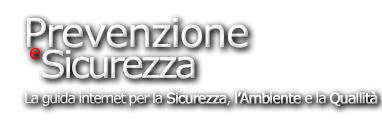News
"L’ottica di genere in un sistema di gestione della salute e sicurezza"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
03/12/2013 - Il percorso INAIL “
Salute e sicurezza sul lavoro, una
questione anche di genere” ha posto più volte il tema delle differenze
correlate all’appartenenza al genere maschile o femminile nel mondo del lavoro.
Percorso che si è evoluto sempre più nella direzione della definizione di un
quadro organico di
linee guida per
una valutazione globale di tutti i rischi nell’ ottica
di genere.
Con questo obiettivo, dopo la
pubblicazione dei due volumi dal titolo “ Salute e
sicurezza sul lavoro, una questione anche di genere. Disegno di linee guida e
primi strumenti operativi”, sono stati pubblicati i successivi volumi:
- Volume III:
Integrazione di genere delle linee guida
per un SGSL;
- Volume IV:
Rischi lavorativi.
Presentiamo brevemente il terzo volume,
dal titolo “
Salute e sicurezza sul
lavoro, una questione anche di genere. Integrazione di genere delle linee guida
per un SGSL. volume 3”, prodotto come nuovo
quaderno tematico della "Rivista degli Infortuni e delle
Malattie Professionali" per migliorare la consapevolezza delle differenze
correlate all’appartenenza al genere maschile o femminile, rispetto alla
sicurezza sul lavoro, in ottica sia di prevenzione che di incidenza
infortunistica.
In particolare nell’intervento dal
titolo “
Un’altra tessera del mosaico
degli strumenti per la salute e sicurezza sul lavoro”, a cura di Antonella
Ninci, si ricorda come l’avvento del D.Lgs. 81/2008 ha “legittimato e
necessitato l’avvio di percorsi che consentano di dare un contenuto, in termini
scientifici e di strumenti di prevenzione, alla ‘
valutazione del rischio connesso al genere’”. Ed è stato dunque necessario
mettere le basi “per un percorso orientato a colmare le lacune di conoscenza,
da un lato, e alla realizzazione di strumenti concreti per la valutazione del
rischio” e le considerazioni, le esperienze e le indicazioni che fanno parte di
questo quaderno, insieme al quarto volume, costituiscono dunque “i prodromi per
il rilascio di linee guida per la valutazione del rischio in ottica di genere”.
In particolare nel presente
volume è presentato un
sistema di
autodiagnosi che intende soddisfare “l’esigenza di integrare in ottica di
genere, da parte del datore di lavoro, il proprio sistema
di gestione della salute e sicurezza. Gli strumenti di auto-valutazione
sono stati messi a punto e sperimentati con alcune aziende private e pubbliche,
quali il Gruppo Sammontana, Pac (società del Gruppo Amadori), Azienda
Ospedaliera di Pisa e lo stesso INAIL - Direzione Regionale Toscana”. E la messa
a punto di tale sistema “ha consentito di individuare alcuni aspetti chiave
quali l’uso a fini prevenzionali dei dati aziendali”.
Vengono offerte dunque offerte,
ai datori di lavoro e a tutti i professionisti della sicurezza, “
indicazioni operative e strumenti utili
ad affrontare in modo appropriato l’impostazione, l’implementazione e il miglioramento
continuo del sistema di salute e sicurezza, a partire dal Sistema
di Gestione della Salute e Sicurezza (SGSL), integrando la prospettiva di
genere nelle diverse fasi cicliche della prevenzione, valutazione e rimozione
dei rischi”. E il processo di valutazione dei rischi in ottica di genere “viene
riletto attraverso una proposta metodologica ed operativa, rinviando, per le
specifiche relative agli standard tecnico-scientifici, alle evidenze che di
volta in volta verranno evidenziate da specifici gruppi di ricerca” e validate
nelle competenti sedi istituzionali.
Il volume contribuisce inoltre all’indagine
sulla esistenza, o meno, “di un reale e motivato
collegamento tra il genere e gli infortuni in itinere”. E per far
questo può essere di indubbia utilità il questionario/intervista “realizzato e
presentato nel quaderno, uno strumento che può consentire ai datori di lavoro,
attraverso l’analisi delle modalità dell’infortunio, ma anche del contesto
sociale nel quale i lavoratori e lavoratrici si muovono, di apprestare misure
di prevenzione non tradizionali, ma non per questo meno efficaci, quali la
flessibilità oraria o altri strumenti di conciliazione vita familiare
e lavorativa”.
L’introduzione di Paola Conti,
ricorda poi che l’integrazione dell’ ottica di
genere nel SGSL e il riconoscimento dell’eccellenza
dell’azienda/organizzazione “implica un Sistema di Gestione della SSL che
evolve in termini di capacità di produrre salute e ridurre i rischi per donne e
uomini, tenendo conto delle loro peculiarità. Tale sistema, deve confrontarsi
con parametri essenziali e significativi di eccellenza” E se i principi sono
universali,le tre dimensioni “individuate per declinare l’analisi della Salute
dal punto di vista organizzativo sono: efficacia, appropriatezza ed equità”.
E in particolare nella
seconda parte del Volume, al
Capitolo tre, “viene descritto il
processo logico della traslazione operativa dell’integrazione di genere,
verificato attraverso una ricerca-azione con le aziende pilota. Tali risultati
hanno permesso di elaborare, e pubblicare, le indicazioni e gli strumenti
contenuti” nella prima parte del Volume “
Guida
all’integrazione di genere dei Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul
lavoro (SGSL)”.
Il
modello di autovalutazione aziendale/organizzativa proposto, “contribuisce
a migliorare la prevenzione, sia per le donne che per gli uomini, e fare in
modo che tutti siano uniformemente protetti” Inoltre conoscenze e strumenti “vengono
messi a disposizione per una valutazione dei rischi che tenga conto delle differenze di
genere prendendo in considerazione le peculiari caratteristiche
(biologiche, sociali e culturali) maschili e femminili, nella loro interazione
con l’organizzazione e l’attività lavorativa: tali differenze sono sottolineate
sia per i rischi più tradizionali (chimici, biologici, fisici, ergonomici), che
per i rischi di carattere organizzativo e psicosociale”. In particolare lo
scopo della “
Mappa degli strumenti per
la valutazione dei rischi in azienda” è quello di “dotare le
aziende/organizzazioni della più adeguata strumentazione, senza costi
aggiuntivi, ottimizzando i processi in essere e valorizzando gli sforzi
compiuti”.
Viene promossa inoltre l’adozione
di un
metodo di prevenzione globale,
“utile a comprendere ex ante, se e come, le scelte organizzative avranno
potenziali diversi effetti sulla salute dei diversi gruppi di popolazione: la
Valutazione di Impatto sulla Salute
Individuale ed Organizzativa (VISIO). Per l’organizzazione che voglia
tendere all’eccellenza, risulta strategico mettere in relazione i dati
aziendali con i dati riguardanti i fenomeni “predittivi”, connessi ai determinanti
di salute. Per agevolare tutti gli attori della prevenzione, le informazioni
significative disponibili verranno, quindi, raccolte nella ‘mappa dei profili
di rischio per comparto’ e nelle ‘schede di rischio per tipologia’, fruibili
attraverso il Portale INAIL”.
Nei
Capitoli dal quarto al settimo del terzo volume le aziende
coinvolte presentano “la propria esperienza di sperimentazione step by step
della metodologia e degli strumenti nel proprio contesto aziendale”.
Per concludere, nella attuale
fase del percorso “
Salute e Sicurezza,
una questione anche di genere”, è “possibile affermare che:
- l’integrazione di genere, in
tutte le fasi e le dimensioni di salute e sicurezza, produce benefici per
l’azienda e per tutti i lavoratori, compresi i lavoratori in condizione di
maggior vulnerabilità;
- integrare una prospettiva di
genere nella formulazione, analisi e monitoraggio delle politiche, dei
programmi, regolamenti e accordi decentrati di applicazione dei contratti
collettivi di lavoro, nelle regole, politiche e misure concrete a livello di
impresa, aiuta tutti coloro che hanno responsabilità per la SSL a fare meglio
il proprio lavoro;
- il prerequisito di un
appropriato ed efficace processo di prevenzione, valutazione e rimozione dei
rischi, è l’integrazione della prospettiva di genere nei SGSL;
- l’ integrazione
del SGSL non può che basarsi su conoscenze e competenze adeguate e
sull’assenza di meccanismi che inducano, anche in modo indesiderato, esiti di
salute diversi tra donne e uomini, o tra gruppi di lavoratori, in diverse
condizioni di vulnerabilità o esposizione ai fattori di rischio;
- ciò introduce alla necessità di
garantire equità di genere in azienda, nel complesso, e tra i diversi gruppi di
lavoratori, in particolare;
- l’equità è garantita, a partire
da una specifica volontà di azione del datore di lavoro e del management, anche
attraverso l’analisi puntuale degli impatti delle scelte organizzative sulla
salute dei lavoratori e delle lavoratrici;
- l’analisi puntuale produce
delle evidenze che vanno a corroborare le scelte aziendali e gli orientamenti
strategici;
- è fondamentale che tali scelte
ed orientamenti vengano adottati non solo sulla base di opinioni (o ancor meno
di stereotipi), ma sulla base di evidenze che solo una corretta ed integrata
analisi dei dati riguardanti il personale, entro ed oltre la valutazione dei
rischi, può offrire”.
L’
indice del terzo volume:
Un’altra tessera del mosaico degli strumenti per la salute e
sicurezza sul lavoro (Antonella Ninci)
Introduzione (Paola Conti)
Parte I - GUIDA ALL’INTEGRAZIONE DI GENERE DEI SISTEMI DI
GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)
1. - L’INTEGRAZIONE DELL’OTTICA DI GENERE NEI SISTEMI DI
GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL) di Paola Conti
1.1. - LE FINALITÀ DELL’INTEGRAZIONE DELL’OTTICA DI GENERE
1.1.1. - I vantaggi dell’integrazione
1.1.2. - L’integrazione del SGSL: tra volontarietà e
obblighi di legge
1.1.3. - L’evoluzione normativa riguardante i SGSL
1.1.4. - Gli ambiti dell’integrazione dell’ottica di genere
nei SGSL
1.2. - IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE
DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
1.2.1. - Dare evidenza dell’ottica di genere nel SGSL
1.2.2. - L’auto-valutazione finalizzata a dare evidenza del
grado di integrazione di genere
1.2.3. - Misurare l’integrazione di genere nel SGSL
1.3. - I PASSI SALIENTI DELL’INTEGRAZIONE DEL SGSL
1.3.1. - Primo passo: analisi di fattibilità
1.3.2. - Secondo passo: analisi delle informazioni raccolte
e posizionamento
1.3.3. - Terzo passo: misurare l’equità in azienda
1.3.4. - Quarto passo: decisione aziendale a seguito del
posizionamento secondo l’Indice
1.4. - PROCESSO DECISIONALE INFORMATO E MIGLIORAMENTO
CONTINUO
1.4.1. - Criticità da affrontare per l’integrazione di
genere
1.4.2. - Opportunità da cogliere attraverso l’integrazione
di genere
1.5. - VISIO PER L’INTEGRAZIONE DEL SGSL DELLE AZIENDE DI
ECCELLENZA
1.5.1. - La VISIO come risorsa per l’integrazione e
miglioramento continuo del SGSL
1.5.2. - Obiettivi della VISIO:
1.5.3. - Cos’è la valutazione dell’impatto sulla salute
individuale ed organizzativa?
1.5.4. - La VISIO quale contributo alla riduzione delle
disuguaglianze di salute
1.5.5. - Che cosa serve per fare la VISIO?
1.5.6. - Quando condurre una VISIO
1.5.7. - Quali sono i passi necessari per la VISIO?
1.6. - IL PERCORSO DELLA VISIO IN DETTAGLIO
1.6.1. - Come iniziare
1.6.2. - Analisi iniziale
1.6.3. - Quali sono i passi necessari per l’analisi
iniziale?
1.6.4. - Approfondimento
1.6.5. - Valutazione
1.6.6. - Formulare raccomandazioni per definire gli
obiettivi e la pianificazione della salute e sicurezza
2. - L’INTEGRAZIONE DELLA PROSPETTIVA DI GENERE NELLA
VALUTAZIONE DEI RISCHI di Breschi Chiara, Paola Conti, Paolo Guidelli, Emilia
Vanni
2.1. - RIFLESSIONI SULL’INTEGRAZIONE DELLE VARIABILI DI
GENERE
2.2. - MAPPA LOGICA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN OTTICA
DI GENERE
2.3. - LA MAPPA LOGICA DEI PROFILI DI RISCHIO PER COMPARTO
2.3.1. - Quadro riepilogativo
2.4. - SCHEDE DI RISCHIO PER TIPOLOGIA
2.4.1. - Piano delle schede
2.4.2. - Descrizione della struttura della scheda
2.5. - IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI IN OTTICA DI
GENERE
2.5.1. - Mappa degli Strumenti per l’integrazione di genere
del DVR
2.6. - IL PROCESSO E LA REDAZIONE DEL DVR-G: MAPPA DEGLI
STRUMENTI
2.6.1. - Prospettive di genere nell’analisi dei Pericoli
2.6.2. - Quadro riepilogativo: MAPPA STRUMENTI VALUTAZIONE
RISCHI AZIENDA
2.7. - L’EVIDENZA DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE DELLA
PROSPETTIVA DI GENERE: IL DVR-G
2.7.1. - Format DVR Integrato (DVR-G©)
Bibliografia di riferimento 97
Parte II - DALLA METODOLOGIA ALLE APPLICAZIONI PRATICHE
3. - L’INTEGRAZIONE POSSIBILE. IL PERCORSO DI
SPERIMENTAZIONE di Paola Conti
3.1. - DALLA METODOLOGIA ALLE APPLICAZIONI PRATICHE:
UN’ACTION RESEARCH
3.2. - OPERATIVIZZARE I CONCETTI ESPRESSI DALLE NORME
3.2.1. - Il processo logico della traslazione operativa
dell’integrazione di genere
3.2.2. - Dal concetto all’operatività
3.2.3. - Qualità del lavoro e salute aziendale
3.2.4. - Visione sistemica e implicazioni sesso-genere
3.2.5. - Valorizzazione delle diversità, non
discriminazione, intersezionalità
3.2.6. - Determinanti di salute ed indicatori aziendali di
salute
3.3. - LA VERIFICA DEL METODO ATTRAVERSO L’ACTION RESEARCH
3.3.1. - La sperimentazione come processo di conoscenza
condivisa
3.3.2. - L’utilizzo dei dati per fare prevenzione
3.3.3. - Un tesoro da maneggiare con cura: i dati del medico
competente
3.3.4. - Gli indicatori organizzativi che producono
informazioni ai sensi del D.Lgs. 81/08
3.3.5. - Indicatori basati sul genere
3.3.6. - Indicatori basati sull’intersezionalità
3.3.7. - L’uso degli indicatori e delle statistiche
3.3.8. - Ottimizzare l’uso dei dati: una chiave per
l’integrazione
3.4. - RIFLESSIONI E PROSPETTIVE
Bibliografia di riferimento
4. - IL CASO DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA PISANA
di Giovanni Ceccanti e Giovanni Guglielmi
4.1. - L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA
4.1.1. - Il personale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Pisana
4.1.2. - Il fenomeno infortunistico e tecnopatico
4.1.2.1. - Il fenomeno infortunistico
4.1.2.2. - Il fenomeno tecnopatico
4.2. - RIFLESSIONI E PROSPETTIVE
4.3. - BENCHMARK: IL PROGETTO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO E
DEI DANNI DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
4.3.1. - Il progetto
4.3.2. - La nuova metodologia proposta
5. - IL CASO DELLA DIREZIONE REGIONALE INAIL PER LA TOSCANA
di Breschi Chiara, Paolo Guidelli, Emilia Vanni
5.1. - L’INFORTUNIO IN ITINERE: ASPETTI ASSICURATIVI
5.2. - I DATI INAIL SUGLI INFORTUNI IN ITINERE
5.3. - APPROFONDIMENTI DI GENERE: INFORTUNI IN ITINERE, UN
MODELLO DI ANALISI
5.3.1. - Il questionario
5.4. - GLI ESITI DELL’INDAGINE IN TOSCANA
Questionario infortuni in itinere
Bibliografia di riferimento
6. - IL CASO DELLA PAC - AMADORI di Paola Bresciani,
Cristina Milano, Italo Rinaldini
6.1. - GRUPPO AMADORI
6.1.1. - Il “laboratorio” di Siena, sinergia fra ricerca e
produzione:la PAC di Monteriggioni
6.2. - VALUTAZIONE DEL RISCHIO COME PROCESSO PARTECIPATO E
PERSONALIZZATO
6.3. - BENCHMARK
6.3.1. - Il caso dei movimenti ripetuti. Un processo di
miglioramento partecipato
6.3.2. - Sistema premiante e SSL
6.3.3. - Soluzioni organizzative per la riduzione dei rischi
(e dei costi)
6.3.4. - Soluzioni semplici per il miglioramento della
qualità della vita e del lavoro
6.3.5. - Le statistiche del personale: un’azienda
fifty/fifty
7. - IL CASO SAMMONTANA di Manfredi Montalti, Gianluca
Persichini
7.1. - LA STORIA DI SAMMONTANA
7.2. - PARTECIPAZIONE AL PROGETTO INAIL “SSL, UNA QUESTIONE
ANCHE DI GENERE”
7.3. - BENCHMARK: POLITICA AZIENDALE PER LA SALUTE, LA
SICUREZZA E L’AMBIENTE
7.4. - APPROFONDIMENTI DI GENERE: L’ANALISI DEI DATI DELLE
CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO
Note sugli autori e autrici
Ringraziamenti
Inail, “ Salute
e sicurezza sul lavoro, una questione anche di genere. Integrazione di genere delle
linee guida per un SGSL. Volume 3”, quaderno della "Rivista degli
Infortuni e delle Malattie Professionali" a cura di Paola Conti e
Antonella Ninci, agosto 2013 (formato PDF, 16.0 MB).
Vai all’area riservata agli
abbonati dedicata a “ Salute e sicurezza sul lavoro: questione anche di genere -
linee guida per un SGSL”.
RTM
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1214 volte.
Pubblicità