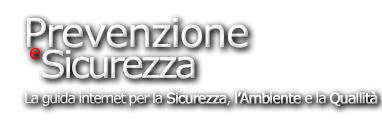News
"Gli ausiliari dell'imprenditore: institore, procuratore e commessi"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
28/02/2014 -
Persone Giuridiche pubbliche e Private
La locuzione
persona giuridica (o, secondo una
vecchia terminologia, ente morale), nel diritto italiano, indica un
complesso organizzato di persone e di beni al quale l'ordinamento
giuridico attribuisce la capacità giuridica, rendendolo soggetto
giuridico.
In generale la capacità giuridica riconosciuta alla persona
giuridica (personalità giuridica) è meno estesa di quella riconosciuta
all'essere umano in quanto soggetto di diritto, ossia alla persona
fisica, poiché la persona giuridica non
può essere parte di quei rapporti giuridici che, per loro natura,
possono intercorrere solo tra persone fisiche (l'esempio tipico è
rappresentato dai rapporti familiari).
Il legislatore del 1942 ha distinto le società di capitali e
le società cooperative, che sono persone giuridiche; la personalità
giuridica è invece stata negata alle società di persone, che godono però
di autonomia patrimoniale.
Con il
riconoscimento
della personalità giuridica, le società (di capitali e le cooperative) sono
trattate, per legge, come soggetti di diritto formalmente distinte dalle persone
fisiche dei soci (riconoscimento di piena e perfetta autonomia patrimoniale). I
beni conferiti dai soci diventano beni di proprietà della società: questa è
titolare di un proprio autonomo patrimonio, di propri diritti e di proprie
obbligazioni distinti da quelli personali dei soci. I creditori personali dei
soci non possono soddisfarsi sul patrimonio sociale, né i creditori sociali
possono soddisfarsi sul patrimonio personale dei soci.
Le società di persone godono di autonomia patrimoniale:
al creditore (insoddisfatto) personale del socio non è permesso aggredire il
patrimonio della società, ma è concesso di ottenere la liquidazione della quota
del proprio debitore; i creditori (insoddisfatti) della società non possono
aggredire direttamente il patrimonio personale dei soci (solo dopo aver
infruttuosamente escusso il patrimonio sociale). Quindi, le obbligazioni
sociali sono obbligazioni della società, cui si aggiunge a titolo di garanzia
la responsabilità di tutti o di alcuni soci. Imprenditore è la società (anche
se il fallimento della società determina il fallimento dei soci illimitatamente
responsabili).
Le persone giuridiche sono tradizionalmente distinte in
pubbliche e private: le prime
perseguono interessi pubblici, mentre le seconde perseguono interessi di
carattere privato, ancorché possano essere utilizzate anche per il
perseguimento di interessi pubblici.
La natura pubblica o privata della persona giuridica si
riflette anche sulla sua disciplina: le persone giuridiche private sono
disciplinate dal diritto privato, mentre quelle pubbliche dal diritto pubblico
che può attribuire loro poteri autoritativi, come quello di emanare
provvedimenti amministrativi (autarchia) o atti normativi (autonomia normativa,
che può essere legislativa, statutaria o regolamentare). Di conseguenza, l'atto
giuridico con il quale si dà vita alla persona giuridica, che prende il nome di
atto costitutivo (nel caso delle
fondazioni è denominato atto di fondazione), ha natura di atto di autonomia
privata nel caso delle persone giuridiche private, mentre nel caso delle
persone giuridiche pubbliche ha natura di provvedimento (amministrativo o in
taluni casi legislativo).
Ausiliari dell'imprenditore
L'imprenditore nello svolgere la propria attività si
avvale della collaborazione di altri soggetti.
Essi possono essere
ausiliari
interni o subordinati oppure
ausiliari
esterni o autonomi.
Nel primo caso si tratta di soggetti che fanno parte
dell'organizzazione aziendale per effetto di un rapporto di lavoro subordinato
che lega gli stessi all'imprenditore.
Nel secondo caso si tratta di soggetti che sono,
prevalentemente, esterni all'organizzazione dell'impresa e che collaborano con
l'imprenditore in modo occasionale o stabile secondo determinati rapporti
contrattuali che possono avere diversa natura, potendo derivare da mandato,
commissione, spedizione, agenzia, mediazione, procura speciale eventualmente
institoria.
Questi soggetti che aiutano l'imprenditore nello svolgere
la propria attività mettendo a disposizione la loro collaborazione rispondono
al nome di
institore,
procuratore e
commessi.
L’institore
La
disciplina
giuridica dell'institore è contenuta nel titolo II "del lavoro
nell'impresa" del libro V "del lavoro" del codice civile
dall'articolo 2203 all'articolo 2205.
L'articolo 2203 rubricato "preposizioni
institoria" recita testualmente: "
E'
institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa
commerciale. La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede
secondaria o di un ramo particolare dell'impresa. Se sono preposti più
institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia
diversamente disposto".
Nel linguaggio comune la figura dell'institore si
identifica con il
direttore generale
dell'impresa o di una filiale o di un settore produttivo della stessa.
Di solito si tratta di un lavoratore subordinato con la qualifica
di dirigente, posto al vertice della gerarchia del personale.
Nel caso sia preposto all'intera impresa dipenderà solo
dall'imprenditore, e solo da lui riceverà direttive e dovrà rendere conto a lui
del suo lavoro.
Nel caso sia preposto ad una filiale o ad un ramo
dell'impresa (ex articolo 2203 comma 2 del codice civile) si potrà trovare in
posizione subordinata rispetto ad un altro institore, ad esempio il direttore
generale dell'intera impresa.
Si può verificare anche il caso che ci siano più
institori preposti nello stesso tempo all'esercizio dell'impresa e in questo
caso essi agiranno disgiuntamente se nella procura non è previsto diversamente
(ex articolo 2203 comma tre del codice civile).
Gli
obblighi
dell’institore si sostanziano nella circostanza che egli è tenuto insieme
all'imprenditore all'adempimento degli obblighi di iscrizione nel registro
delle imprese e di tenuta delle scritture contabili (ex articolo 2205 del
codice civile), e in caso di fallimento dell'imprenditore saranno applicate
anche nei confronti dell’institore le sanzioni penali a carico del fallito (ex
articolo 227 legge fallimentare), tenendo presente che solo l'imprenditore
potrà essere dichiarato fallito e soltanto lui sarà esposto agli effetti
personali e patrimoniali che derivano dal fallimento.
L'institore ha inoltre il
potere di rappresentanza sostanziale e processuale.
Nel caso della rappresentanza sostanziale anche senza
espressa procura, egli può compiere in nome dell'imprenditore tutti gli atti
pertinenti all'esercizio dell'impresa o del ramo al quale è preposto, non può
invece compiere atti che travalicano dalla gestione dell'impresa, ad esempio la
vendita o l'affitto dell'azienda oppure il cambiamento dell'oggetto
dell'attività e non può vendere oppure ipotecare i beni immobili del preponente
se non è stato specificamente autorizzato.
Nel caso della rappresentanza processuale, l’institore
può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto per le obbligazioni
che dipendono da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa alla quale è
preposto (ex articolo 2204 comma 2 del codice civile), quindi non soltanto per
gli atti compiuti da lui ma anche per gli atti posti in essere direttamente
dall'imprenditore.
I poteri rappresentativi determinati dalla legge nei confronti
dell’institore possono essere ampliati oppure limitati dall'imprenditore sia
all'atto della preposizione sia successivamente.
I procuratori
La
disciplina
giuridica dei procuratori è contenuta nel titolo II "del lavoro
nell'impresa" del libro V "del lavoro" del codice civile
all'articolo 2209 rubricato "procuratori".
L'articolo 2209 del codice civile recita testualmente:
"
Le disposizioni degli articoli 2206
e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali in base a un rapporto
continuativo, abbiano il potere di compiere per l’imprenditore gli atti
pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso".
I procuratori di conseguenza sono coloro che secondo un
rapporto continuativo, hanno il
potere
di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa.
Essi sono quindi ausiliari subordinati e sono di
grado inferiore rispetto all’institore
perché a differenza dello stesso, non sono posti a capo dell'impresa o di un
ramo di una sede secondaria, e non sono degli ausiliari con funzioni direttive
perché il loro potere decisionale è circoscritto a un determinato settore
dell'impresa.
Costituiscono esempi di procuratori: il direttore del
settore acquisti, il dirigente del personale, il direttore del settore
pubblicità.
Il procuratore non ha la rappresentanza processuale
dell'imprenditore neppure negli atti che sono stati posti in essere da lui
stesso, e non è soggetto agli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese
e della tenuta delle scritture contabili.
Mandato e Mandante
Il mandato è il contratto con cui una parte (
il mandatario) si obbliga a compiere
uno o più atti giuridici nell'interesse dell'altra parte (
il mandante), come recita l'articolo 1703 del codice civile. Nella
maggior parte dei casi è oneroso, dunque prevede l'elargizione di un compenso –
che può essere fissato dalle parti oppure determinato in base alle tariffe
professionali – a favore del mandatario.
Il mandato è previsto con rappresentanza o senza
rappresentanza e sempre in forma scritta se riguarda beni immobili. In caso di
mandato con rappresentanza, il mandatario agisce in nome e per conto del
mandante. Con il mandato senza rappresentanza, il mandatario agisce in nome
proprio, acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal negozio. I
terzi non hanno alcun rapporto col mandante al quale, in un secondo tempo, il
mandatario, in virtù del mandato ricevuto, trasferirà ciò che ha acquistato o
le somme riscosse.
Esistono diverse
specie
di mandato. Rispetto ai poteri che sono attribuiti alle parti, può essere
generale se riguarda tutti gli affari
del mandante,
generico se riguarda
determinate categorie o
specifico se
riguarda un solo atto giuridico. Rispetto ai soggetti, invece, il mandato può
essere
collettivo quando viene
conferito da più persone a un solo mandatario, con un unico atto e
nell'interesse comune a ogni mandante. Può essere
congiuntivo se conferito a più persone destinate ad agire
congiuntamente, o disgiuntivo se conferito a più mandatari operanti
separatamente. Per quanto riguarda la distinzione in base agli interessi
curati, il mandato può essere nell'interesse esclusivo del mandante,
nell'interesse del mandante e del mandatario o nell'interesse del mandante e di
terzi.
Il mandatario è tenuto ad assolvere il suo compito nel
miglior modo possibile senza eccedere dai limiti fissati nel contratto,
rendendo note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare
la revoca o la modifica del mandato. A mandato eseguito, il mandatario deve
immediatamente avvisare il mandante e presentare il rendiconto. Dal canto suo,
il mandante è tenuto a mettere nelle migliori condizioni possibili di azione il
mandatario fornendogli tutti i mezzi necessari, rimborsando le spese e, infine,
pagando il compenso pattuito.
E quando si estingue un mandato? Se scade il termine o se
l'affare viene portato a termine innanzitutto. E poi per revoca da parte del
mandante, per rinunzia del mandatario (che deve risarcire i danni in assenza di
una giusta causa), per morte, interdizione o inabilitazione del mandatario o
del mandante.
La delega di funzioni, il delegante e il delegato
La delega di
funzioni per definizione è: “l’atto organizzativo interno
all’impresa, con il quale un soggetto a ciò abilitato (delegante) – in presenza
di determinati requisiti oggettivi e soggettivi, positivi e negativi –
trasferisce ad un altro soggetto (delegato) doveri originariamente gravanti su
di lui, il cui omesso o negligente impedimento può dare luogo a responsabilità
penale (ALDOVRANDI, Orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia di
delega di compiti penalmente rilevanti, in Riv. Trim. Dir. Pen., 1995, 699).
La delega è stata dunque individuata, rispetto a
strutture complesse quali quelle imprenditoriali, come
strumento per meglio organizzare l’attività lavorativa e gli obblighi
in materia di sicurezza, ripartendo anche le relative responsabilità.
Il delegante attraverso la delega di funzioni riduce fortemente la propria responsabilità sul piano penale, ma non
totalmente.
La sua posizione di garanzia è esclusa e sostituita da
quella del delegato per quanto riguarda tutti i compiti validamente delegati,
gli resta solo l’obbligo di assicurare un idoneo sistema di vigilanza
sull’attività del delegato, al fine di non incorrere in responsabilità per
culpa in vigilando, come prevede da
tempo immemorabile la giurisprudenza, e più recentemente l'art. 16, comma 3 del
Decreto legislativo 81/2008.
In mancanza di un idoneo sistema di vigilanza il
delegante risponde per omessa vigilanza rispondendo in proprio dell’eventuale
reato omissivo o commissivo del delegato, se si tratta, ad esempio, di reati di
sicurezza sul lavoro o ambientali.
L'
obbligo di
vigilanza non può essere analitico, cioè essere così penetrante e costante
al punto da sostanziarsi nell’adempimento dell’obbligo stesso di cui il
delegante è originario destinatario, perché sarebbe una ingerenza incompatibile
con la volontà di trasferire effettivamente l proprie funzioni e compiti
prevenzionistici.,
Ai sensi dell’art. 16, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, “l’ obbligo di vigilanza gravante in capo al soggetto delegante in ordine al corretto espletamento
delle funzioni da parte del delegato si intende assolto in caso di adozione ed
efficace attuazione del modello di verifica e controllo previsto dall’art. 30,
comma 4 del medesimo Testo Unico”.
Infatti l’adozione di un
modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. n.
231/2001, “che preveda un sistema di controllo circa la sua attuazione e
mantenimento, concreta il rispetto da parte del delegante dell’obbligo di
controllo sul soggetto delegato”.
Con una delega di
funzioni debitamente accettata, in forma scritta e con data
certa, il delegato subentra e sostituisce il delegato, quanto ai compiti
delegati validamente, quale soggetto responsabile titolare di una posizione di
garanzia. Il delegato è tenuto pertanto a svolgere le funzioni delegate
adempiendo alle prescrizioni normative ed attivandosi per prevenire il
verificarsi di eventi lesivi nei termini previsti dalla delega di funzioni.
L'esercizio delle funzioni delegate comporta la
responsabilità penale del soggetto delegato sia in ordine ai reati comuni, sia
in ordine ai reati propri, ossia quelle fattispecie criminose nelle quali è
richiesto in capo al soggetto attivo del reato una determinata qualifica (es.
datore di lavoro). Da ciò ne deriva che, pur non ricoprendo formalmente la
qualifica richiesta, il delegato, in ragione della delega e della posizione di
garanzia con essa assunta, risponde del reato in base al principio
di effettività che determina l’individuazione dei soggetti
responsabili, trai quali vi è anche il delegato del datore di lavoro.
L’art. 16, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 prevede e
disciplina la “subdelega”, cioè la possibilità del delegato di delegare a sua
volta specifiche funzioni ad altro soggetto in materia di salute e sicurezza
sul lavoro. Quest’ultimo tuttavia non potrà effettuare alcuna ulteriore
subdelega.
I commessi
la
disciplina
giuridica dei commessi è contenuta nel titolo II "del lavoro
nell'impresa" del libro V "del lavoro" del codice civile
all'articolo 2210 rubricato "poteri dei commessi dell'imprenditore".
L'articolo 2210 del codice civile recita testualmente:
"
I commessi dell'imprenditore, salve
le limitazioni contenute nell'atto di conferimento della rappresentanza,
possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni
di cui sono incaricati. Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci
delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non
sono d'uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati".
I commessi sono ausiliari subordinati ai quali sono
affidate
mansioni esecutive oppure
materiali e si mettono di persona in contatto con i terzi.
Costituiscono un esempio di commessi: i commessi di
negozio, i commessi viaggiatori, gli impiegati di banca addetti agli sportelli,
i camerieri
dei bar oppure dei ristoranti.
In virtù della loro posizione i commessi possono svolgere
la rappresentanza dell'imprenditore anche senza specifico atto di conferimento
della stessa, ma questo potere di rappresentanza è più limitato rispetto al
potere dell’institore e dei procuratori.
Stando all'enunciato dell'articolo 2210 comma 2 del
codice civile essi possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la
specie di operazioni delle quali sono incaricati.
I commessi non possono esigere il prezzo delle merci se
queste non sono da essi stessi consegnate, né concedere dilazioni o sconti che
non siano d'uso.
Se sono preposti alla vendita nei locali dell'impresa non
possono esigere il prezzo fuori dai locali dell'impresa stessa, e non lo
possono esigere all'interno dell'impresa se alla riscossione del prezzo è
diretta un'apposita cassa.
L'imprenditore da parte sua può sia ampliare sia limitare
i poteri dei commessi.
Approfondimento
Amministratore, institore e datore di lavoro.
In caso di nomina di un institore al quale non siano per
di più attribuiti esplicitamente incarichi in materia di sicurezza del lavoro,
si può agevolmente individuare la persistenza di
due posizioni di garanzia, in qualità di datori di lavoro,
all'amministratore unico che ha effettuato la nomina, e all'institore medesimo,
per quanto riguarda gli obblighi prevenzionistici e protezionistici in materia
di salute e sicurezza dei lavoratori. La cassazione è esplicita:
nominando l'institore l'amministratore non
perde i suoi poteri di direzione, per di più non gli ha conferito
esplicitamente e in via esclusiva i compiti in materia di sicurezza e igiene
del lavoro, cosa che avrebbe potuto invece fare, perciò se ne assume tutte le
conseguenze: “
sia l'imprenditore che
l'institore da lui nominato hanno il potere di licenziare il personale -
Attraverso la preposizione institoria il titolare non perde il potere di
direzione dell'impresa - In base all'art. 2103 cod. civ. è institore colui che
è preposto dal titolare dell'impresa all'esercizio della medesima. In base
all'art. 2204 cod. civ. l'institore può compiere tutti gli atti inerenti
all'esercizio dell'impresa. La procura institoria non richiede forme solenni né
è essenziale, per l'acquisto della qualità di institore, la sussistenza di un
rapporto di lavoro subordinato con l'imprenditore. Attraverso la preposizione
institoria l'imprenditore non perde il potere di direzione dell'impresa. Tra i
poteri dell'institore vi è quello del licenziamento dei lavoratori subordinati.
Tuttavia, nominando un institore, l'imprenditore non si priva del potere di
provvedere anche personalmente al licenziamento” (Cassazione Sezione Lavoro
n. 3022 del 27 febbraio 2003, Pres. D'Angelo, Rel. Roselli).
Occorre anche ricordare, con una importante sentenza
della cassazione nel c.d. caso Galeazzi, quanto segue: "nel
caso di una società di capitali originariamente il datore di lavoro (in senso
civilistico) va individuato nel consiglio
di amministrazione o nell'amministratore unico. Ove, con la nomina di uno o
più amministratori delegati, si verifichi il trasferimento di funzioni in capo
ad essi, non per questo va interamente escluso un perdurante obbligo di
controllo della gestione degli amministratori delegati; ciò trova un importante
argomento di conferma, sia pure sul piano civilistico (con conseguenze che,
peraltro, non possono che riflettersi su quello penalistico comune essendo la
matrice e la giustificazione degli obblighi di garanzia), nel testo dell'art.
2392 c. 2 cod. civ. che ribadisce, anche nel caso di attribuzioni proprie del
comitato esecutivo o di uno o più amministratori, la solidale responsabilità
degli amministratori (di tutti gli amministratori) «se non hanno vigilato sul
generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti
pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o
eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose».
Obblighi attenuati ma ribaditi anche nel nuovo testo
dell'art. 2392 cod. civ. introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 che ha
riformato il diritto societario con entrata in vigore il 1 gennaio 2004. In
base ad un criterio di ragionevolezza si preferisce escludere che questo
obbligo riguardi anche gli aspetti minuti della gestione, senza porre però in
dubbio l'
esigibilità di un dovere di
vigilanza sul generale andamento della gestione. Si riferisce a tale
generale andamento non l'adozione di una singola misura di prevenzione per la
tutela della salute di uno o più lavoratori o il mancato intervento in un
singolo settore produttivo ma la complessiva gestione aziendale della sicurezza.
Dunque con il
trasferimento
di funzioni (come anche nella delega di funzioni) il contenuto della
posizione di garanzia gravante sull'obbligato originario si modifica e si
riduce agli indicati obblighi di controllo e intervento sostitutivo: ove l'amministratore
non adempia a tali obblighi residuali e, in conseguenza di questa omissione, si
verifichi l'evento dannoso si dovrà ravvisare la colpa nell'inosservanza di
tali obblighi. Ma se ciò avviene addirittura per i componenti del consiglio di
amministrazione che hanno validamente e formalmente trasferito (con la c.d.
delega «interna» di cui all'art. 2381 cod. civ. anche nella più recente
formulazione) la più parte delle funzioni in questione non si vede perché non
debba ritenersi, anche ammessa la validità di un patto interno tra i
coobbligati alla sicurezza, la permanente esistenza dell'obbligo di vigilanza e
controllo da parte del coobbligato e che debba addirittura richiedersi la
formalizzazione di questa riserva.
In conclusione,
in
un sistema che si fonda su un assetto che esclude la delegabilità di
determinate funzioni in tema di sicurezza, e che comunque prevede un residuo
obbligo di controllo da parte di coloro cui originariamente è attribuita la
qualità di datore di lavoro,
non è
ipotizzabile che residui un'area di irresponsabilità in base ad accordi,
formali o meno che siano, o addirittura dedurre dall'inerzia un trasferimento
di funzioni con efficacia giuridica escludente la responsabilità pervenendo al
risultato di esonerare taluno dalla responsabilità penale in base ad un atto di
autonomia privata [Cassazione sezione quarta penale - Sentenza n. 4981 del 6
febbraio 2004 (u.p. 5 dicembre 2003) - Pres. Fattori - Est. Brusco - P.M. (P. Diff.) lannelli
- Ric. P.M. in e. - Res. Ligresti e altri].
Rolando
Dubini, avvocato in Milano
Note bibliografiche:
G. Campobasso - Manuale di Diritto Commerciale -
GIUFFRE’ 2011
Codice Civile - GIUFFRE’ 2012
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1286 volte.
Pubblicità