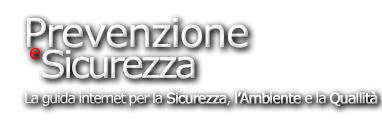News
"Materiali di riporto e test di cessione: quali limiti si applicano?"
fonte www.puntosicuro.it / RIFIUTI
15/03/2016 -
1.
Premessa
Il “caso” dei
materiali di riporto (o, come si esprime la legge, delle «
matrici
materiali di riporto») è senza dubbio paradigmatico dell’approccio – spesso
episodico, se non addirittura “emotivo” – alle problematiche ambientali da
parte delle istituzioni, siano esse la magistratura, le amministrazioni o lo
stesso legislatore. Ovviamente non si può generalizzare ed esistono lodevoli
eccezioni, ma l’esperienza insegna che il modo di procedere è stato in molti
casi il medesimo: emerge un problema di natura tecnica, si individua una lacuna
legislativa (vera o presunta) e si tenta di colmarla attraverso interpretazioni
eccessivamente restrittive o irragionevolmente “prudenziali” (secondo una
malintesa interpretazione del principio di precauzione) della normativa
esistente, inducendo il legislatore ad intervenire con norme “emergenziali” per
risolvere la situazione di stallo che si è così venuta a creare.
Tutti ricorderanno cosa accadde per i
materiali di riporto: in assenza di una specifica disciplina, alcuni
anni fa si venne a creare nel territorio milanese una situazione critica a
seguito della posizione assunta dalla Procura nel corso di alcune indagini
penali – poi generalizzata dalla Provincia di Milano – secondo la quale i materiali di riporto
sarebbero stati da considerare a tutti gli effetti (giuridicamente) “rifiuti”
e, in quanto tali, da rimuovere (ci si riferisce all’ordine di servizio della
Provincia di Milano prot. n. 214914 del 29 novembre 2010 che stabiliva che i
materiali di riporto dovessero essere «
considerati
e trattati come rifiuti»).
A questo
proposito – trattandosi di posizione superata, come si dirà, dall’evoluzione
della normativa – è appena il caso di osservare come la disciplina in materia
di bonifiche (a partire dal previgente DM 471/1999) [1]
già contenesse al suo interno numerosi riferimenti ai materiali di riporto e,
pertanto, rappresentasse,
a legislazione
invariata, la cornice normativa più consona all’interno della quale
ricondurre anche questa problematica, allo scopo di individuare soluzioni
tecnicamente, ambientalmente ed economicamente più ragionevoli della integrale
rimozione dei materiali in questione, rimozione imposta sul presupposto che si
trattasse
sempre e comunque di
rifiuti abbandonati.
Per
fronteggiare la situazione critica di cui sopra, il legislatore ha ritenuto
necessario introdurre una norma
ad hoc,
ossia l’
art. 3 del
decreto-legge 2/2012 (su cui lo stesso
legislatore è intervenuto a più riprese [2]).
Questa disposizione contiene l’
interpretazione autentica
[3] dell’art. 185 del d. lgs. 152/2006 (che indica i casi di esclusione dall'ambito
di applicazione della Parte Quarta
del medesimo decreto) e, nella
versione oggi vigente:
·
definisce
le
matrici materiali di riporto come
la «
miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e
scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte
stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e
stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la
realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri»
·
riconduce tali materiali al concetto di «
suolo»
ai fini dell’applicazione dell’art. 185 del d. lgs. 152/2006 e al concetto di «
matrici
ambientali» di cui all’art. 240, d. lgs. 152/2006 ai fini
dell’applicazione anche alle matrici
materiali di riporto della disciplina in materia di bonifica dei siti
contaminati (Titolo V della Parte Quarta del d. lgs. 152/2006 e relativi
allegati);
·
prevede
che le matrici materiali di riporto debbano «
essere sottoposte a
test di cessione effettuato sui
materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro
dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare
per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi
ai limiti del test di cessione, [debbano]
rispettare quanto previsto
dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati»
(comma 2);
·
stabilisce
che «
le matrici materiali di riporto che
non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono
fonti di contaminazione e come tali
devono essere
rimosse o devono
essere
rese conformi ai limiti del
test di cessione tramite operazioni di
trattamento
che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a
messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche
disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo
la destinazione urbanistica senza rischi per la salute» (comma 3).
A seguito dell’introduzione di questa
specifica normativa, la Provincia di Milano ha dichiarato decaduto il
proprio ordine di servizio del 2010 e il Tribunale penale di Milano, con
sentenza 30 agosto 2013, n. 13/1776, ha potuto affermare quanto segue: «
l’intervenuta interpretazione autentica
dell’art. 185, comma 1 lett. b) D.Lgs. 3.4.06 n. 152 – certamente retroattiva
proprio perché autentica – ha fugato ogni dubbio sulla qualificazione dei
materiali di riporto, escludendoli dall’ambito di applicazione della disciplina
sui rifiuti. Ogni questione sul punto è davvero superata dall’ulteriore novum
legislativo intervenuto tra la deliberazione e il deposito della presente
sentenza (….) l’art. 41 comma 3 lett. a) decreto-legge 21.6.13 n. 69,
convertito con modificazioni dalla legge 9.8.13 n. 98».
Ciò
premesso, in questo contributo intendiamo soffermarci su alcune problematiche
interpretative suscitate dalla citata disciplina sulle matrici materiali di riporto
e, in particolare, sulla posizione assunta di recente dal TAR Lombardia,
sede di Milano, rispetto ai limiti ai quali riferirsi nell’esecuzione
del test di cessione.
2.
Il caso affrontato dal TAR Milano
Con
sentenza
n. 2638 del
14 dicembre 2015, il
TAR Milano è stato chiamato a pronunciarsi in merito alla legittimità del
provvedimento con cui il Comune, nell’approvare un Piano di caratterizzazione,
aveva richiesto – allineandosi al parere espresso dall’ARPA – che i materiali
di riporto rinvenuti nel sito venissero sottoposti a test di cessione
confrontandone gli esiti con le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)
di cui alla tabella 2 dell’allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del d.
lgs. 152/2006.
Questa richiesta è stata contestata dal ricorrente,
il quale – in sintesi – aveva lamentato che l’atto del Comune richiedesse «
la
sottoposizione dei materiali di riporto ad una verifica ulteriore e diversa da
quella espressamente richiesta dalla normativa vigente, ossia il rispetto dei
valori delle concentrazioni soglia di contaminazione che il codice
dell’ambiente fisserebbe solo per le acque sotterranee, dunque per una matrice
ambientale totalmente differente dai materiali di riporto in questione»;
ciò perché – secondo il ricorrente – il citato comma 3 dell’art. 3 «
farebbe
espresso riferimento ai limiti dei test di cessione individuati all’allegato 3
del D.M. 5 febbraio 1998, senza lasciare spazio all’applicazione di altre
disposizioni normative». Non solo: era stato altresì evidenziato come, nel
caso specifico, il parere dell’ARPA si ponesse in contraddizione con un
precedente parere reso dalla medesima Agenzia con riferimento alla stessa
vicenda nel quale era stato stabilito che nel test di cessione da eseguirsi sui
materiali di riporto dovessero essere applicati i limiti di cui al DM 5
febbraio 1998 (che, è appena il caso di ricordarlo, rappresenta la normativa
tecnica di riferimento per le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi
esercitate in “regime semplificato”, in forza degli articoli 214 e 216, d. lgs.
152/2006).
Il
nocciolo
della questione affrontata dal TAR Lombardia (Milano) può essere
sintetizzato nella seguente domanda:
il
test di cessione che, in forza del citato art. 3, occorre seguire sui materiali
di riporto deve prendere a riferimento i limiti fissati dal DM 5 febbraio 1998
(come sosteneva il ricorrente) o quelli stabiliti dalla tabella 2 dell’allegato
5 al Titolo V della Parte Quarta del d. lgs. 152/2006 (come sostenevano l’ARPA
e il Comune)?
Il problema si pone, ovviamente, nel caso in
cui, applicando gli uni o gli altri limiti, il test di cessione sortisca esiti
differenti e, in particolar modo, nel caso in cui – com’era accaduto nella
vicenda posta al vaglio del TAR Milano – i materiali di riporto sottoposti a test
di cessione risultino conformi ai limiti previsti dal DM 5 febbraio 1998, ma
non anche ai valori di cui alla citata tabella 2.
3.
La posizione assunta dal TAR Milano sui limiti applicabili al test di cessione da
eseguirsi sui materiali di riporto
Il TAR Milano ha rigettato il ricorso e, per
rispondere alla domanda sopra riportata, ha ricordato che «
il test di
cessione è rappresentato da una prova simulata di rilascio di contaminanti,
effettuata ponendo in contatto per un tempo definito un solido con un
lisciviante (agente separatore) e separando quindi le due fasi per ottenere un
eluato (liquido prodotto all’esito del test)» e sottolineato come, a suo
dire, il comma 2 dell’art. 3 del decreto-legge 2/2012 non opererebbe un
generico rinvio al DM 5 febbraio 1998, trattandosi di un rinvio limitato
all’art. 9 «
ai fini delle metodiche [e non dei parametri] da utilizzare per
escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee». Secondo il
TAR, quindi, tale disposizione «
da un lato, circoscrive l’ambito oggettivo
del rinvio al decreto ministeriale alle sole “metodiche da utilizzare” e,
dall’altro, indica chiaramente la finalizzazione del test, ovvero escludere i
rischi di contaminazione delle acque sotterranee», osservando poi che «
gli
specifici e puntuali limiti da rispettare in relazione alle acque sotterranee
si rinvengono oggi esclusivamente nella Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V
della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006».
4.
Perché la posizione del TAR Milano non convince
La posizione assunta dal TAR
Milano non sorprende, ma, allo stesso tempo, non appare esente da critiche.
Non sorprende perché ricalca
l’interpretazione fornita dallo stesso Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare in una “nota di chiarimenti” del 14 maggio 2014
indirizzata all’ISPRA (si tratta, è bene precisarlo, di un atto privo di
qualsivoglia valenza normativa e che, in ogni caso, non vincola in alcun modo i
privati; è altresì lecito dubitare che possa assumere valore cogente nei
confronti di amministrazioni, quali sono le Regioni e gli Enti locali, non
gerarchicamente sottoposte al Ministero).
Non convince, invece, per più
ordini di ragioni:
1) in
primo luogo, limitandosi allo specifico caso affrontato dal tribunale
amministrativo milanese, appare singolare che il giudice non abbia ritenuto
necessario esprimersi sulla denunciata (dal ricorrente) contraddizione in cui,
nel caso di specie, era incorsa l’ARPA, la quale – stando a quanto riportato
nella stessa sentenza – in un precedente parere del 2014 (dunque, espresso in
un momento in cui la disposizione sui materiali di riporto era già in vigore
nella attuale formulazione) aveva ritenuto che i materiali di riporto dovessero
essere verificati mediante test di cessione svolto ai sensi dell’art. 9 del DM 5
febbraio 1998; il “cambio di rotta” dell’ARPA è stato presumibilmente
determinato dalla diffusione della citata nota ministeriale, ma ciò non toglie
che il legittimo affidamento nel frattempo ingenerato nel ricorrente circa la
correttezza del proprio operato avrebbe meritato maggiore considerazione;
2) in
secondo luogo, e più in generale, non appare del tutto persuasiva l’esegesi
fornita dal TAR in ordine al tenore letterale del comma 2 dell’art. 3 del decreto-legge 2/2012, in cui non sembra,
infatti, obiettivamente possibile scorgere alcuna limitazione – alle sole
metodiche, e non anche ai parametri ed ai valori da prendere a riferimento nel
test di cessione – al rinvio operato al DM 5 febbraio 1998; è vero, infatti,
che il comma 2 specifica «
ai fini
delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle
acque sotterranee», ma è altrettanto vero che subito dopo aggiunge «
ove conformi ai
limiti del test di cessione», ed è evidente che «i limiti del
test di cessione» non possono che essere quelli previsti dal DM 5 febbraio 1998, dal momento che la
normativa in materia di bonifiche non contempla limiti specifici per il
test di cessione (come fa, invece, l’allegato 3 del citato DM, che in una
apposita tabella indica i «valori limite» con cui raffrontare i risultati del
test in questione), né dispone un utilizzo generalizzato di siffatto test ai
fini della verifica del rispetto delle CSC (un accenno al test di cessione è
presente, invero, nell’allegato 2 al
Titolo V della Parte Quarta del d. lgs. 152/2006, ma soltanto come possibile
metodica, utilizzabile oltretutto in alternativa ad altre, in casi specifici,
vale a dire per eventuali indagini integrative finalizzate alla migliore
definizione del Modello Concettuale Definitivo del sito e «
mirate alla definizione dei parametri sito specifici necessari per
l'applicazione dell'analisi di rischio ed eventualmente alla migliore
calibrazione dei modelli di calcolo impiegati, che non sia stato possibile
caratterizzare con le indagini iniziali»);
3) in terzo luogo, ci sembra che l’argomento
(utilizzato anche dal Ministero dell’ambiente nella citata “nota di
chiarimenti” del 14 maggio 2014)
secondo cui la necessità di far riferimento alle CSC stabilite dalla tabella 2
dell’allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del d. lgs. 152/2006 deriverebbe
dall’obiettivo di fondo del test di cessione, vale a dire escludere rischi di
contaminazione delle acque
sotterranee, non tenga conto del fatto che è lo stesso comma 2 dell’art. 3
a puntualizzare che «
le matrici materiali di riporto (…) ove conformi ai
limiti del test di cessione, devono
rispettare quanto previsto dalla
legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati», con ciò separando
nettamente le due verifiche, l’una finalizzata ad accertare il rispetto degli
specifici limiti del test di cessione (ossia, quelli appositamente stabiliti
dall’allegato 3 del DM 5 febbraio 1998), l’altra ad appurare
anche il
rispetto delle CSC fissate dalla normativa sulle bonifiche. In ogni caso, l’affermazione
– desumibile dalla sentenza del TAR di Milano – secondo la quale l’applicazione
al test di cessione (in quanto, appunto, «
prova simulata di rilascio di
contaminanti, effettuata ponendo
in contatto
per un tempo definito un solido con un lisciviante») dei limiti delle CSC
previsti per le acque
sotterranee sarebbe l’unico modo di procedere in linea con la finalità ultima
della norma, ossia escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee,
appare esageratamente cautelativa (e, dunque, a tacere d’altro, poco rispettosa
del principio di proporzionalità). Ogni situazione che si verifica nella
pratica presenta, infatti, dei connotati peculiari; non si può quindi
presupporre in modo generalizzato che i materiali di riporto
entrino
sempre
e comunque a diretto contatto con la matrice ambientale “acque sotterranee”
e che, dunque, il rilascio di contaminanti – dovuto a fenomeni di lisciviazione
– al di sopra dei valori delle CSC determini
sempre e comunque una
contaminazione della falda. È evidente, infatti, che vi sono situazioni in cui
tale eventualità non può concretamente verificarsi (ad esempio, in ragione del
livello di profondità della falda o della presenza, al di sotto dei materiali
di riporto, di uno strato di suolo dotato di un elevato grado di
impermeabilità). Sarebbe pertanto più sensato rimettere queste valutazioni, di
natura eminentemente tecnico-discrezionale, alla sede del contraddittorio
procedimentale;
4) in quarto luogo, va rilevato come la
posizione del TAR non consideri – presumibilmente perché l’argomentazione non
era stata prospettata dal ricorrente in questi termini – che lo stesso DM 5 febbraio 1998 prevede per molte
tipologie di rifiuti la possibilità che gli stessi vengano utilizzati “tal
quali” in operazioni di recupero ambientale (R10), vale a dire ai fini
della «
restituzione di aree degradate ad
usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici» (art. 5, DM 5 febbraio 1998), subordinando questa forma di recupero
proprio all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto secondo il già citato allegato
3 del medesimo decreto. Ora, è del tutto evidente che non ha alcun senso –
pena, altrimenti, dover riconoscere l’esistenza di un’insanabile contraddizione
all’interno dell’ordinamento – vietare, attraverso l’applicazione della
disciplina sui materiali di riporto, il mantenimento
in loco di
materiali risultati conformi al test di cessione secondo i limiti di cui
all’allegato 3 del DM 5 febbraio 1998 ma non anche ai limiti della tabella 2
dell’allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del d. lgs. 152/2006, dal
momento che si tratta di materiali che, in forza del DM 5 febbraio 1998,
potrebbero essere utilizzati – stante, appunto, la conformità degli stessi al
test di cessione di cui al citato allegato 3 – proprio per seguire operazioni
di recupero ambientale R10 [4];
5) infine,
può essere utile segnalare che la posizione del TAR non considera –
presumibilmente perché neppure questa argomentazione era stata prospettata dal
ricorrente – che, in sede di
discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 91/2014, il
Senato aveva approvato, in data 25 luglio 2014, un emendamento mediante il
quale, fra le altre cose, aveva proposto di integrare il testo dell’art. 3 del decreto-legge 2/2012 inserendovi al
comma 3 la precisazione «
qualora le concentrazioni attese in falda,
valutate mediante modelli di lisciviazione e dispersione in falda,
superino i limiti di cui alla tabella 2
dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152». Questo
emendamento, tuttavia, non è stato mantenuto nel testo definitivo della legge di
conversione del decreto-legge 91/2014 e, di conseguenza, il suddetto
inciso non è stato inserito nel più volte menzionato art. 3 del decreto-legge 2/2012. Tale circostanza
sembra evidentemente confermare la volontà del legislatore di escludere che i
limiti da prendere a riferimento siano quelli di cui alla tabella 2
dell’allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del d. lgs. 152/2006.
5. Il TAR Milano ha
però definitivamente chiarito che i materiali di riporto non sono – di per sé –
“rifiuti”
Al di là delle criticabili conclusioni a cui
è pervenuto rispetto ai limiti da considerare nel test di cessione, il TAR
Milano ha però opportunamente chiarito (ci si augura, in modo definitivo) un
aspetto che, nella prassi, viene talvolta ancora messo in discussione.
Ci si riferisce al passaggio in cui la
sentenza afferma che «
per le matrici materiali di riporto vige un regime
particolare: quando presentano caratteristiche non conformi ai limiti dei test
di cessione esse vengono qualificate "fonti di contaminazione" e come
tali devono essere trattate, secondo le modalità specificate nell’art. 3, comma
3 del D.L. n. 2/2012.
In altre
parole: la qualificazione dei materiali di riporto come "fonti di
contaminazione" prevale sulla qualificazione di "matrici
ambientali" e impone di intervenire su tali materiali con le specifiche
modalità previste dal citato art. 3 comma 3 (norma speciale), anziché con le
procedure ex artt. 242 ss. del Codice dell'ambiente (cfr. T.A.R. Toscana, II, 7
aprile 2015, n. 558)». Il tutto,
per respingere l’assunto del ricorrente secondo il quale l’applicazione dei
limiti di cui alla tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del
d. lgs. 152/2006 avrebbe necessariamente portato, in caso di “fallimento” del
test di cessione (rispetto ai predetti limiti), a considerare come “rifiuti” i
materiali di riporto.
Da questo ragionamento si può pertanto
desumere che, anche secondo il TAR Milano, i materiali di riporto risultati non
conformi al test di cessione non devono necessariamente essere qualificati e
gestiti come rifiuti, ma restano – appunto – assoggettati alla peculiare
disciplina di cui al più volte citato art. 3, decreto-legge 2/2012 (il «
regime
particolare» di cui parla il TAR Milano), che si discosta sia dal generale
regime dei rifiuti, sia da quanto normalmente stabilito dalla normativa in
materia di bonifica dei siti contaminati.
6. Le procedure
applicabili nel caso in cui i materiali di riporto “falliscano” il test di cessione, ma siano conformi alle CSC
Da ultimo, pare opportuno soffermarsi su un aspetto controverso rispetto
al quale la normativa non appare sufficientemente chiara e non constano, a
tutt’oggi, precedenti giurisprudenziali.
Esso riguarda la procedura amministrativa applicabile nel caso in cui le
matrici materiali di riporto abbiano “fallito” il test di cessione (ciò a
prescindere dai limiti presi a riferimento), ma siano allo stesso tempo
risultate conformi alle CSC. Secondo la nostra esperienza, si tratta di
un’eventualità tutt’altro che rara. Il problema si pone, ovviamente, soltanto
nel caso in cui appaia più ragionevole – sotto il profilo tecnico, ambientale
ed economico – realizzare un intervento (nello specifico, un’operazione di
trattamento volto a rimuovere i contaminanti o una messa in sicurezza
permanente, interventi entrambi espressamente legittimati dall’art. 3, comma 3,
decreto-legge 2/2012) diverso dalla semplice rimozione delle stesse.
Ci si chiede, nello specifico, se, nel silenzio della norma, al
fine di poter realizzare un siffatto intervento, il relativo progetto debba
essere preventivamente approvato nell’ambito di un ordinario procedimento
amministrativo di bonifica disciplinato dal Titolo V della Parte Quarta del d.
lgs. 152/2006. Numerosi elementi inducono a ritenere che, in tali casi, non sia
applicabile la normativa in materia di bonifiche.
Ciò perché, laddove le matrici di
riporto rispettino le CSC, manca il presupposto indefettibile per
l’applicazione della disciplina di cui al Titolo V della Parte Quarta del d.
lgs. 152/2006, consistente – appunto – nel superamento delle concentrazioni
soglia di rischio (CSR) o, quanto meno, delle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC). Va infatti considerato che, secondo l’art. 239, il quale definisce il campo di applicazione del
citato Titolo V, «
il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e
ripristino ambientale dei siti contaminati (…)» e che, in forza del
successivo art. 240, è considerato «sito contaminato» soltanto quello «
nel
quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con
l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla
parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di
caratterizzazione, risultano superati».
Non solo, è interessante notare che il già citato emendamento del
Senato del 25 luglio 2014 relativo al disegno di legge di conversione del
decreto-legge 91/2014 aveva proposto anche di integrare il testo dell’art. 3 del decreto-legge 2/2012 inserendo, dopo le
parole «
devono essere rimosse o», l’inciso «
in alternativa,
attivando
le procedure di cui al titolo V, della parte quarta del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152». In altre parole, questo inciso prevedeva
espressamente di assoggettare alle procedure disciplinate dalla
normativa in
materia di bonifica dei siti contaminati (Titolo V della Parte Quarta
del d.
lgs. 152/2006 e relativi allegati) anche le operazioni di trattamento e
gli interventi di messa in sicurezza permanente delle matrici materiali
di riporto, a
prescindere dal superamento delle CSC (circostanza, quest’ultima, che
avrebbe
infatti di per sé richiesto l’attivazione delle suddette procedure).
Anche il
predetto emendamento, tuttavia, non è stato mantenuto nel testo
definitivo
della legge di conversione del decreto-legge 91/2014 e, pertanto,
l’inciso
di cui sopra non è stato inserito nell’art. 3, decreto-legge 2/2012. Ciò
conferma ulteriormente la volontà del
legislatore di escludere dal campo di applicazione della disciplina in
materia
di bonifiche le operazioni
di trattamento e gli interventi di messa in sicurezza permanente delle
matrici materiali di riporto che siano
risultate conformi alle CSC. La conseguenza, sotto il profilo
procedimentale, è
che in questi casi troverà applicazione la disciplina generale di cui
alla legge
241/1990.
Mara
Chilosi e Andrea Martelli
avvocati
[1] Secondo
il D.M. n. 471 del 1999 (regolamento attuativo dell’art. 17 del D. Lgs. n. 22
del 1997 (cd. «Decreto Ronchi») i materiali di riporto non sono rifiuti e ad
essi si applica la disciplina in materia di bonifica dei siti contaminati:
•artt. 4, co. 4 e 5, co. 4: «Gli interventi di
bonifica [con misure di sicurezza] e ripristino ambientale di un sito inquinato
devono privilegiare il ricorso a tecniche che favoriscano la riduzione della
movimentazione, il trattamento nel sito ed il riutilizzo del suolo, del
sottosuolo e dei materiali di riporto sottoposti a bonifica»
•allegato 1: (in particolare) «I valori di
concentrazione limite accettabili sono riferiti a suolo, sottosuolo e materiali
di riporto del sito e influenzati dalla contaminazione del sito…»
•allegato 2 : (in particolare) «Per ogni matrice
ambientale investigata (suolo, sottosuolo, materiali di riporto, acque
sotterranee, acque superficiali, atmosfera del suolo) e per gli ammassi di
rifiuti stoccati, si possono presentare due principali strategie per
selezionare l'ubicazione dei punti di sondaggio e prelievo…»; «La profondità
del prelievo di suolo, sottosuolo o materiali di riporto varia con la necessità
di caratterizzare l'area dal punto di vista geologico e idrogeologico, di
definire la profondità dell'inquinamento, la variabilità orizzontale e
verticale della contaminazione, …»; «Nel caso di presenza di materiali di
riporto (quali scorie di fonderia, ceneri, materiali di demolizione, materiali
terrosi), l'ubicazione dei campionamenti dovrà permettere di caratterizzare
ogni porzione di territorio occupata da tali materiali, il loro stato di
contaminazione e le caratteristiche chimico-fisiche di tali materiali che
possono influire sui successivi trattamenti di bonifica»; «Gli Elaborati da
allegare alla relazione delle attività di investigazione iniziale comprendono:
… c) Mappatura dell'inquinamento di suolo, sottosuolo, materiali inerti o di
riporto e acque di falda… »; «Sulla base di questa formulazione vengono prese
in esame: a) le diverse tecniche di bonifica che possono essere adottate per
ridurre le concentrazioni nel suolo, nel sottosuolo, nei materiali inerti o di
riporto, nelle acque sotterranee e superficiali ai valori di concentrazione
limite accettabili per la destinazione d'uso prevista per il sito…»
Anche negli allegati al Titolo V della Parte Quarta
del d. lgs. 152/2006 si rinvengono numerosi riferimenti (espliciti o impliciti)
ai materiali di riporto. In particolare, nell’Allegato 2 (normativa mai
modificata sotto questo profilo) si legge quanto segue: «Le fonti potenziali di
inquinamento sono definite sulla base del Modello Concettuale Preliminare del
sito e comprendono: luoghi di accumulo e stoccaggio di rifiuti e materiali, (…)
Quando sono oggetto di indagine rifiuti interrati, in particolare quando sia
prevista la loro rimozione e smaltimento come rifiuto, si procederà al prelievo
e all'analisi di un campione medio del materiale estratto da ogni posizione di
sondaggio. (…) L'elaborazione dei risultati analitici deve esprimere l'incertezza
del valore di concentrazione determinato per ciascun campione: in
considerazione della eterogeneità delle matrici suolo, sottosuolo e materiali
di riporto la deviazione standard per ogni valore di concentrazione
determinato, da confrontare con i valori di concentrazione limite accettabili,
dovrà essere stabilita sulla base del confronto delle metodologie che si
intendono adottare per il campionamento e per le analisi dei campioni di
terreno e di acqua. (…) d) privilegiare le tecniche di bonifica che permettono
il trattamento e il riutilizzo nel sito anche dei materiali eterogenei o di
risulta utilizzati nel sito come materiali di riempimento; (…) j) per la messa
in sicurezza privilegiare gli interventi che permettano il trattamento in situ
ed il riutilizzo industriale dei terreni, dei materiali di risulta e delle
acque estratte dal sottosuolo, al fine di conseguire una riduzione del volume
di rifiuti prodotti e della loro pericolosità; (…) Nelle operazioni di messa in
sicurezza devono essere privilegiate le soluzioni tecniche che consentano di
minimizzare la produzione di rifiuti e pertanto favoriscano: (…) il riutilizzo
nel sito come materiali di riempimento anche dei materiali eterogenei e di
risulta».
[2] Esso
è stato, infatti, modificato dapprima mediante la legge 28/2012 (di conversione
del decreto-legge 2/2012) e, in seguito, dall’art. 41 del decreto-legge 69/2013
e dalla legge di conversione del predetto decreto (legge 98/2013).
[3] Poiché
si tratta di una norma di interpretazione autentica, esso ha efficacia
retroattiva. Le norme di interpretazione autentica hanno, infatti, proprio lo
scopo di chiarire, in situazioni di oggettiva incertezza e/o quando vi sia già
un contrasto giurisprudenziale, il significato di una determinata norma e la
loro efficacia retroagisce perciò alla data di entrata in vigore della norma
interpretata (nel nostro caso, l’art. 185 del d. lgs. 152/2006, che è in
vigore, nelle parti che qui rilevano, dal 2010);
[4] Il
ragionamento non cambia nemmeno considerando che il citato art. 5, D.M. 5
febbraio 1998 precisa che l’utilizzo dei rifiuti in operazioni di recupero
ambientale deve essere «compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche,
idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare» e che, «in ogni caso,
il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione
vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei
siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d’uso del sito». Con
riferimento ai materiali di riporto, infatti, la prima verifica può essere
svolta caso per caso, e la seconda corrisponde con quella – comunque necessaria
– volta appurare il rispetto delle CSC nella stessa matrice in questione.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1068 volte.
Pubblicità