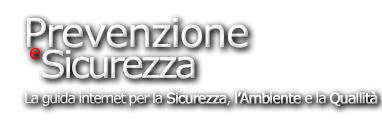News
"Il rispetto della normativa garantisce la qualità della formazione?"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
22/03/2016 - Se, come denunciato dalla Consulta Interassociativa CIIP,
nel “mercato” della formazione alla sicurezza sono presenti anche
prodotti/percorsi che non sono conformi agli obblighi normativi, che non
tengono conto dei “bisogni formativi”, che sono affidati a formatori non qualificati, è bene riflettere attentamente sulle strategie e le soluzioni necessarie per migliorare la situazione e la
qualità della formazione alla sicurezza in Italia.
Ed è per questo motivo che riprende l’
inchiesta sulla formazione che il nostro giornale sta portando avanti, ormai da alcuni mesi, elaborando articoli, raccogliendo pareri, pubblicando documenti e realizzando diverse interviste per mettere in luce e approfondire buone prassi, criticità e proposte.
Dopo aver intervistato nei giorni scorsi l’avvocato Rolando Dubini,
sulla rilevanza di una buona o cattiva formazione nelle aule di
tribunale, abbiamo rivolto alcune domande ad una delle persone che in
Italia conoscono meglio il tema della salute e sicurezza e sanno come è
percepito tra chi contribuisce direttamente all’aggiornamento e
all’evoluzione della normativa italiana. Parliamo di Lorenzo Fantini,
giuslavorista che per diversi anni è stato Dirigente divisione Salute e
sicurezza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
A lui chiediamo innanzitutto un commento sulla formazione vista
attraverso il D.Lgs. 81/2008 e gli Accordi Stato-Regioni, sulle attuali
criticità e sulle necessarie norme e integrazioni per migliorare la
formazione. Ma ne approfittiamo anche, basandoci sulla sua lunga
esperienza lavorativa al ministero, per comprendere i ritardi e le
prospettive future della revisione degli Accordi sulla formazione degli RSPP e ASPP del 26 gennaio 2006.
Articolo e intervista a cura
di Tiziano Menduto.
Il legislatore ha tenuto sufficientemente conto, almeno con riferimento
al D.Lgs. 81/2008, dell’importanza di una formazione alla sicurezza efficace e
di qualità per migliorare la prevenzione nei luoghi di lavoro?
Lorenzo Fantini: La
regolamentazione
delle attività formative da parte del d.lgs. n. 81/2008 è stato uno degli
obiettivi che gli estensori del provvedimento hanno avuto quale riferimento, anche
con riguardo alle esperienze non positive dell'applicazione del d.lgs. n.
626/1994 in materia. In particolare, la legge tende a enfatizzare l'aspetto
della necessità che la formazione (non a caso definita all'articolo 2 del
d.lgs. n. 81/2008 quale "processo educativo") produca un
accrescimento di competenze in capo al
discente, che egli potrà utilizzare per svolgere al meglio i propri compiti
"in sicurezza" in azienda.
Per ovviare, poi, all'eccesso di
deregulation - ritenuta fonte di abusi -
si è ritenuto nel 2008 di far riferimento agli
Accordi in Conferenza Stato-Regioni per la definizione
"dettagliata" delle regole della formazione dei soggetti del sistema
di prevenzione aziendale, in modo da identificare in modo uniforme in Italia
contenuti e procedure della formazione in materia di salute e sicurezza e
limitare l'elusione dell'obbligo prevenzionistico, essenziale a prevenire i
c.d. "comportamenti pericolosi" (come noto assolutamente determinanti
per causare - o almeno concorrere a causare - infortuni e malattie
professionali).
La normativa mi pare chiara al
riguardo e se essa ha un difetto va rinvenuta nella
scarsa attenzione alla identificazione di elementi di valutazione della
qualità dell'attività formativa di tipo moderno e che vadano oltre le
formule generali e, per loro natura, opinabili e oggetto di interpretazioni non
agevoli e diversificate (si pensi, per tutte, alla previsione di cui
all'articolo 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 che
prevede che la formazione del lavoratore debba essere "sufficiente e
adeguata").
Gli Accordi in materia di formazione hanno risolto tutte le
problematiche e hanno chiarito tutti i dubbi in materia di formazione?
L.F.: A mio parere
le
criticità più ampie in materia si rinvengono proprio negli Accordi, sia in
quanto essi non brillano (lo dico anche con un certo senso di colpevolezza, in
quanto negli anni in cui gli Accordi sono stati elaborati e pubblicati ero parte
di una delle Amministrazioni competenti, in quanto dirigente presso il
Ministero del lavoro) per brevità e chiarezza sia perché - per quanto allo
scopo (sicuramente apprezzabile) di rendere meno semplice che in passato
l'elusione del dettato normativo - i parametri per distinguere la buona dalla
cattiva formazione sono stati individuati in modo sin
troppo formale e burocratico, ad esempio tenendo conto del numero
minimo di ore complessivo dell'attività formativa obbligatoria. I dubbi che
rimangono sono, peraltro, tanti come ho modo di constatare giornalmente
nell'ambito della mia attuale attività di consulenza professionale alle imprese
e ai professionisti.
In definitiva il Testo Unico e l’applicazione degli Accordi
Stato-Regioni non sono in grado oggi di garantire che la formazione erogata
nelle aziende sia una buona formazione?
L.F.: L'applicazione puntuale dei dettati del "testo
unico" e degli accordi in materia di formazione è sicuramente un buon
inizio (peraltro obbligatorio), ma diciamo che “
è condizione necessaria ma non sufficiente” perché la formazione
erogata sia efficace a fini prevenzionistici.
Ce lo ricorda, del resto,
costantemente la
giurisprudenza (tra
le ultime sentenze cito, per tutte, la n. 18444 del 2015 della Cassazione
penale, sezione IV, nella quale si evidenzia come la formazione debba essere
specifica rispetto alle mansioni svolte e non solo formalmente rispettosa delle
previsioni legali) che in caso di infortunio non si ferma affatto alle
documentazioni che attestano il regolare svolgimento dell'attività formativa ma
cerca di comprendere se quella attività formativa sia stata correttamente
progettata, efficacemente erogata e verificata quanto a "impatto" sul
discente.
Le aziende e gli operatori della
prevenzione debbono sempre ricordare che
la
formazione è misura che discende direttamente dalla valutazione dei rischi
e che è in base a quest'ultima che dovrebbe procedersi alla elaborazione di
percorsi formativi adeguati rispetto alle esigenze di prevenzione e tutela dei
soggetti da formare.
Altro elemento che emerge con
forza dalla lettura delle
sentenze di
condanna (di solito a carico di datori di lavoro e dirigenti ma talvolta
anche di RSPP)
per inefficace formazione
è la necessità che alla formazione si accompagni - quando ciò emerga da una
corretta valutazione dei rischi - l'addestramento, altra misura fondamentale a
prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e che troppo
spesso viene erroneamente omessa (magari in quanto ritenuta
"assorbita" dalla formazione).
Ci soffermiamo ora su chi dovrà scrivere o aggiornare la normativa
futura. Secondo lei viene data a livello ministeriale la giusta attenzione ai
problemi della formazione?
L.F.: Il Ministero del lavoro ha sempre attribuito, e sono certo
che attribuisca tuttora, ampia importanza alla formazione. Piuttosto, il
problema è più generale, legato alla
fine
di un periodo - che a questo punto (a costo di risultare forse noiosamente
nostalgico) mi pare quasi irripetibile -
in
cui la salute e sicurezza sul lavoro è stata portata non dico tra le priorità
del Paese ma sicuramente tra le questioni politiche e sociali meritevoli di
attenzione.
Penso che il principale
protagonista di quel periodo sia stato il Presidente Napolitano che quasi
giornalmente accendeva i riflettori sulla prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali. Oggi, invece, siamo tornati allo stato ante 81/2008,
con una rilevanza mediatica e politica della salute e sicurezza molto bassa.
Sempre in relazione alla normativa futura e attesa, come si spiegano i
grandi ritardi dell’aggiornamento degli Accordi in materia di formazione
RSPP/ASPP?
L.F.: Da un lato il "sistema" delle Regioni non è una
entità uniforme e unitaria e, quindi, non ha la stabilità necessaria per agire
in modo rapido e deciso, dall'altro lato è inevitabile che l'intero assetto
delle competenze in materia di salute e sicurezza risenta dell'incertezza della
devoluzione delle competenze
costituzionali in materia.
Voglio dire che se la riforma
della Costituzione al momento in Parlamento prevede che la materia della salute
e sicurezza - ad oggi attribuita in modo "ripartito" tra Stato e
Regioni - torni al solo Stato è logico che la cosa non sia incentivante per
chi, in Conferenza Stato-Regioni, è chiamato a lavorare sugli Accordi...
Riguardo alla revisione degli Accordi RSPP/ASPP, che avrebbe dovuto
operare sensibili cambiamenti anche sulla formazione più in generale dei
lavoratori, sono sorte secondo lei divergenze su specifici aspetti relativi
alla formazione?
L.F.: Ancora una volta la spiegazione più semplice è quella
corretta. Sono sufficientemente certo che il testo degli Accordi sulla
formazione di RSPP/ASPP sia stato da tempo totalmente condiviso dai
"tecnici" di Stato e Regioni, per cui il problema è solo politico...
Certo, però, che questo ritardo
pone tutti in grande difficoltà, solo in piccola parte attutita da qualche
risposta ad interpello, a chiarimento di aspetti controversi in materia di
formazione e salute e sicurezza sul lavoro.
Secondo la sua esperienza quando e “come” sarà possibile arrivare alla
definitiva revisione degli accordi RSPP/ASPP?
L.F.: Qui l'incertezza è totale, per le ragioni già esposte. Voglio
dire che non solo non si può prevedere quando l'Accordo uscirà ma neppure SE
uscirà (almeno prima che cambi la Costituzione).
Torniamo all’erogazione della formazione in Italia. Ci sono i dati per
fare un confronto sulla qualità e tipologia della formazione erogata in Italia
rispetto agli altri paesi dell’Unione Europea?
L.F.: non ne ho mai avuti al Ministero e non mi risulta che ve ne
siano, al momento. Qualche passo in avanti è stato fatto a livello di normativa
sulle qualifiche professionali e anche il decreto "qualificazione
formatori" è un passo in avanti rispetto al passato; tuttavia, manca una
volontà di procedere ad una
classificazione
di formatori e processi formativi in una dimensione europea, quanto mai
necessaria in un contesto lavorativo sempre più transnazionale. Un esempio per
tutti: i Paesi europei - salvo rare eccezioni - non riconoscono condizione di
reciprocità alle attestazioni relative alla formazione in materia di salute e
sicurezza conseguite in Italia...
Nei rami del Parlamento si è affrontato, attraverso interrogazioni
parlamentari, il tema della formazione alla sicurezza e della scarsa
rappresentatività di alcuni enti bilaterali e organismi paritetici? Con che
risultati?
L.F.: devo dire che questo è uno dei principali rimpianti che ho,
nel senso che mi sarebbe piaciuto aiutare aziende ed operatori ad avere
indicazioni chiare sulla natura e sulle funzioni degli organismi paritetici.
In realtà, nel 2012 venne
elaborato una bozza di decreto ministeriale, all'esito di una non semplice
attività di confronto con le parti sociali, che prevedeva la
creazione di un elenco di organismi
paritetici riconosciuti dal Ministero del lavoro e, quindi, affidabili.
Del provvedimento, a mio parere
importante, si sono perse le tracce, credo per mancanza di volontà di andare a
toccare
interessi economicamente
significativi; voglio dire che la responsabilità del Ministero del lavoro
(che avrebbe dovuto gestire l'elenco informatico degli organismi paritetici) -
in assenza di una normativa (che pure l'articolo 39 della nostra Costituzione
prevede) legale sulla rappresentatività - è stata ritenuta evidentemente dai
vertici dell'Amministrazione troppo elevata essendo stata, evidentemente,
minimizzata l'importanza del tema per le aziende.
Al riguardo segnalo che nel 2013
come ufficio "tecnico" del Ministero del lavoro proponemmo di
inserire nel " decreto
del fare" una norma che potesse chiarire il significato dell'obbligo
di collaborazione con gli organismi paritetici alla attività di formazione di
lavoratori e RLS ma la norma venne stralciata dal testo poi approvato perché
considerata, rispetto ad altre (es.: il chiarimento, a mio parere di
limitatissimo rilievo, sull'esenzione dall'obbligo di redazione del DUVRI) di
scarsa importanza.
Veniamo infine a quanto raccontato dalla Consulta CIIP sulle “ampie
zone di elusione e evasione degli obblighi normativi relativi alla formazione
con il ricorso a soluzioni di mera apparenza e il rilascio di attestati
formativi di comodo”... Secondo lei cosa sarebbe necessario fare al Ministero
per cercare di porre un freno a questi percorsi formativi “fraudolenti”? E
perché non è stato fatto fino ad oggi?
L.F.: Sono totalmente d'accordo con la segnalazione, che giorno per
giorno verifico essere corrispondente alla realtà. Va, però, detto che le
aziende più serie ed accorte non si prestano a "risparmiare" sulla
formazione, magari anche solo per timore di conseguenze negative in un giudizio
per infortuni sul lavoro o per malattia professionale. Insomma, vedo una
grossa corresponsabilità delle aziende,
alle quali andrebbe chiesta la ragione per la quale si cerca di risparmiare
oltre ogni logica e ragionevolezza su una attività essenziale in termini
prevenzionistici.
Il Ministero del lavoro potrebbe
facilitare il quadro regolatorio (ad esempio, come detto, rispetto agli
organismi paritetici) e le Regioni, tramite le ASL, potrebbero pensare a una
campagna ad hoc di vigilanza,
incentrata sulla verifica della qualità della formazione e non solo sulla forma
della medesima. Tali attività non sono state fatte finora per le ragioni già
esposte e anche perché progettare una attività ispettiva con maggior
discrezionalità e, quindi, più contestazioni non è facile né immediato.
Quali sono gli aspetti dei percorsi formativi su cui potrebbe essere
necessario intervenire a livello normativo per favorire una loro migliore
qualità?
L.F.: Bisogna insistere sulla
qualificazione
dei docenti, figure fondamentali per una buona formazione, andando verso
una vera e propria qualificazione di stampo europeo.
Occorre, poi, ribadire la
necessità della
coerenza tra valutazione
di rischi e formazione ed enfatizzare il momento della verifica di
apprendimento. Per me un percorso formativo è davvero efficace quando - a
distanza di tempo dal corso erogato - il discente, a seguito di verifica,
dimostra di avere interiorizzato quanto ha ascoltato durante il corso o
l'aggiornamento.
Cosa ne pensa, infine, delle proposte CIIP? Saranno ascoltate?
L.F.: Sono il larga parte condivisibili e spero sinceramente che
vengano considerate, anche se non vedo all'orizzonte "veicoli
normativi" nelle quali esse possano essere inserite (sempre per la scarsa
rilevanza politica del tema della salute e sicurezza in questo momento).
Peraltro, come ho spesso detto
pubblicamente, ritengo che la CIIP possa avere, spero nell'immediato futuro, un
ruolo essenziale per indirizzare i decisori verso una più moderna gestione
della salute e sicurezza sul lavoro. Il futuro della materia sta, infatti,
nella crescita dell'apporto dei "
tecnici"
sulla regolamentazione e nella diminuzione della disciplina generale ed
astratta a favore di quella pratica e specialistica; insomma, meno leggi e più
buone prassi e indicazioni operative, tratte dall'esperienza e rese applicabili
a situazioni analoghe.
Ricordiamo alcuni recenti articoli di PuntoSicuro relativi all’attuale
situazione della formazione alla sicurezza in Italia:
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 917 volte.
Pubblicità